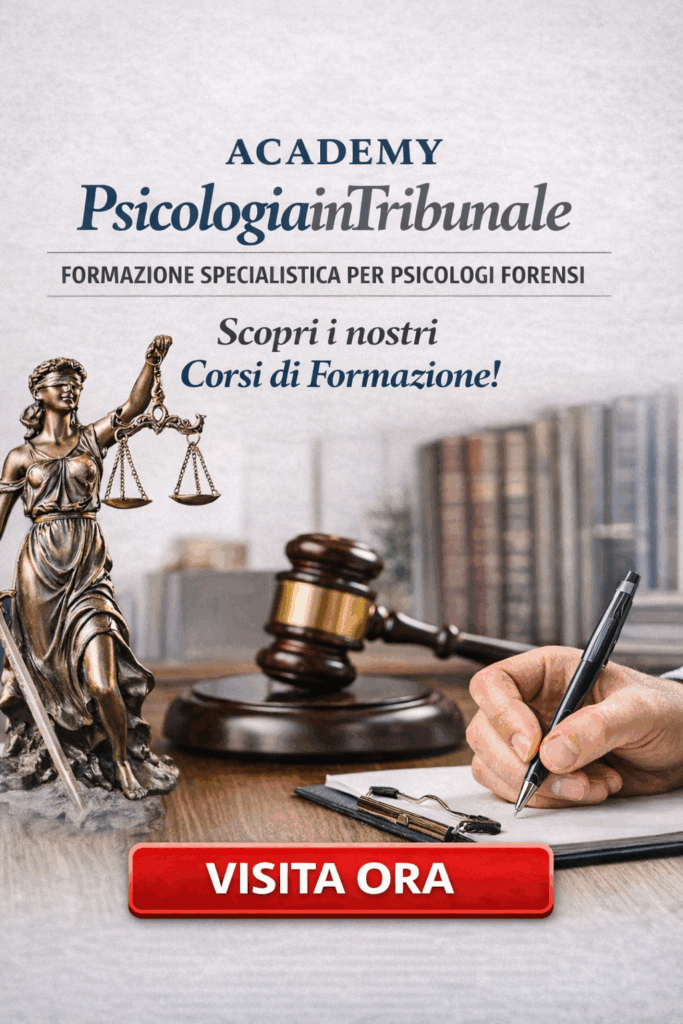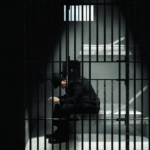Suicidio in carcere, quale ruolo per lo psicologo esperto ex art. 80?
Ogni caso di suicidio in carcere è sempre frutto di una storia complessa e determinata da più fattori. Però, quando i numeri individuano un problema specifico, sicuramente indicano il malessere di un sistema che necessita profondi cambiamenti.
Laura Monteleone, psicologa giuridica esperta della Rete di Psicologia in Tribunale, è stata per anni consulente psicologa ex art. 80 presso il Ministero della Giustizia presso le sedi di U.S.S.M. di Gela (CL) e presso l’Istituto penale per Minorenni di Bicocca–Catania, dove ha svolto anche attività di osservazione e trattamento dei minori ristretti.
Con lei abbiamo provato a comprendere meglio il contesto delle carceri e come è strutturato il lavoro degli operatori del settore?

Laura Monteleone
Psicologa Giuridica e Forense, Psicoterapeuta
Per anni psicologa ex art. 80, attualmente, si occupa di consulenze tecniche in ambito giudiziario in tema di separazione e adozioni, sia nel ruolo di CTU che di CTP.
Come è organizzato il carcere e come operano gli addetti ai lavori in funzione della prevenzione del suicidio?
La vita dei detenuti all’interno degli istituti penitenziari segue i tempi e le regole di un’organizzazione istituzionale complessa che scandisce i ritmi di chi vive al suo interno. In queste strutture esistono dei circuiti differenziati, distinti sulla base delle esigenze di trattamento dei reclusi e delle necessità di custodia correlate al grado di pericolosità. Mi riferisco ai diversi livelli di sicurezza: alta sicurezza, A.S , media sicurezza, M.S e custodia attenuata.
A seconda delle sezioni dove è più opportuno o necessario collocare il detenuto, si attuerà un piano di trattamento e anche di osservazione che, soprattutto nel caso di “alta sicurezza”, prevede l’attuazione di una sorveglianza rafforzata e l’impossibilità di contatti con detenuti ristretti in altri circuiti. I condannati per reati conseguenti ad attività di organizzazioni criminali sono costretti a percorsi complessi per accedere alla fruizione di benefici e misure alternative.
Anche se in regimi di sorveglianza diversi da quello di alta sicurezza, il detenuto ha la possibilità di interagire in primis con il personale della sicurezza, la polizia penitenziaria, che resta l’interlocutore privilegiato. Per questo è fondamentale la costante collaborazione tra questi operatori e tutto il personale destinato al trattamento (professionisti dell’area psico-pedagogica) affinché il detenuto sia sempre monitorato anche nel suo stato emotivo e di salute psichica e ascoltato nei suoi bisogni.
Il sovraffollamento o la stessa tipologia di reato spesso causano la necessità di trasferimenti e quindi di allontanamento dal contesto geografico di riferimento, ma soprattutto familiare. L’impossibilità, quindi, di accedere costantemente ai colloqui può determinare in alcuni un maggior sentimento di solitudine e di abbandono, incrementando, in particolare, sentimenti di colpa e di inadeguatezza. In un sistema dove si registra la discrepanza tra la moltitudine della popolazione carceraria e un numero inadeguato di figure professionali specifiche per l’ascolto e l’intervento su questo tipo di disagi è più facile che il detenuto si chiuda in un isolamento disadattivo e cada in stati depressivi, che magari non vengono colti dal sistema.
Ogni istituto dovrà verificare che lo stato dei piani regionali e locali di prevenzione sia in linea con il Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti, che prevede sempre uno staff multidisciplinare, composto dal direttore, dal comandante, dall’educatore, dal medico e dallo psicologo. Allo staff è assegnato il compito di monitorare e valutare le situazioni a rischio, individuando protocolli operativi utili a far emergere quelli che vengono definiti “eventi sentinella”. L’attenzione dell’equipe sarà centrata sui fatti e sulle specifiche circostanze che possono risultare spie di un disagio che deve mettere in allerta, onde evitare possibili gesti estremi.
Che ruolo hanno gli psicologi e sono abbastanza quelli che operano nel sistema penitenziario?
Gli istituti penitenziari devono prevedere nel loro organigramma un numero di figure professionali dell’area psicopedagogica adeguato a poter fornire risposte all’intera popolazione detentiva, con l’attuazione di piani di intervento anche personalizzati, qualora l’osservazione della “persona” detenuto lo necessiti. Il sistema detentivo/penitenziario prevede la figura dello psicologo sia all’interno del suo organico sia avvalendosi di professionisti esterni, come esperti ex art. 80. È comunque necessario che chi presta la sua opera professionale all’interno di una istituzione complessa come quella carceraria abbia competenze adeguate, frutto di una formazione specifica in tema di psicologia giuridica, di un buon bagaglio esperienziale e, non ultimo, di capacità di ascolto e di empatia. Questi sono requisiti o, se vogliamo, competenze fondamentali per affrontare il dialogo e sviluppare la relazione di aiuto all’interno dei sistemi complessi, dove la richiesta di ascolto e di aiuto deve essere saputa cogliere spesso nel non detto e nella lettura di comportamenti e dinamiche interne all’istituzione stessa. In particolare, la possibilità che in organico siano presenti più psicologi permette di essere frequentemente in contatto con i detenuti, consentendo più colloqui e quindi monitorando anche lo stato di salute psichica dei soggetti. Forse, a volte, quelli che sembrano dare “meno problemi” a livello di gestione della condotta possono essere osservati con minore sollecitudine, mentre è proprio in questi soggetti che si sviluppano sentimenti di colpa e di inadeguatezza alla vita. Quindi poter osservare e fornire relazioni di ascolto e di aiuto, intervenendo anche attraverso metodologie quali gruppi di parola, attività di arteterapia o laboratori ricreativi, oltre che con colloqui individuali, permette anche di poter agire sul disagio esistenziale del detenuto in maniera di adeguata e più congrua anche rispetto ai piani trattamentali stessi.
Esiste un problema di salute mentale sottostimato in carcere?
Il disturbo psichico è di gran lunga la prima categoria diagnostica nelle carceri italiane. L’associazione Antigone ha rilevato che il 13% del totale della popolazione detenuta ha una diagnosi psichiatrica grave, che, in numeri assoluti, significa oltre 7.000 persone; e un detenuto su due ha comunque disagio psichico.
È per questo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene che uno dei punti focali per la prevenzione del suicidio sia quello di fornire un’attenzione privilegiata alla salute mentale dei detenuti. Il disagio mentale, secondo il Progetto ME.D.I.C.S., determina difficoltà di integrazione nella comunità̀ carceraria. La conoscenza dello stato di salute dei reclusi ha quindi la possibilità di modulare il regime carcerario attraverso l’ausilio di servizi sanitari dentro e fuori dal carcere.
Dalla nostra Academy
Allegato
Riepilogo delle strategie più efficaci per la prevenzione del suicidio in carcere dell’OMS
«Innanzitutto, le conoscenze e la collaborazione del personale carcerario sembrano essere elementi cruciali per l’avvio di un programma efficace di prevenzione del suicidio nelle carceri. Le migliori tattiche si basano sullo sviluppo e la documentazione di un piano generale di prevenzione del suicidio, che raccolga i seguenti elementi:
- Un programma di addestramento (e di aggiornamento) per il personale di custodia e per gli operatori sanitari che li aiuti a riconoscere i detenuti con crisi suicidarie.
- Deve essere posta particolare attenzione all’ambiente carcerario, considerando i suoi livelli di attività, di sicurezza, di cultura, e il tipo di rapporto tra agenti e detenuti. Nello specifico, la qualità del clima sociale è di importanza critica nel ridurre al minimo i comportamenti suicidari. Anche se le carceri non potranno mai essere ambienti privi di stress, le autorità dovrebbero attuare delle strategie efficaci per ridurre il bullismo ed altre forme di violenza nelle loro istituzioni, e enfatizzare invece relazioni supportive tra detenuti e personale carcerario. La qualità del rapporto tra agente e detenuto è di cruciale importanza per ridurre il livello di stress dei detenuti e per fare in modo che i detenuti stessi siano portati con fiducia a comunicare i momenti in cui le loro forze reattive stanno per essere sopraffatte, provano disperazione o si sviluppa in loro un intento suicidario.
- Procedure di screening sistematico dei detenuti sia all’ingresso che durante la detenzione, per identificare gli individui con un rischio elevato.
- Strategie per favorire la comunicazione e le informazioni tra il personale carcerario sui soggetti a rischio.
- Procedure scritte che riportino i requisiti minimi per ospitare detenuti ad alto rischio; fornire supporto sociale; frequenti controlli visivi e osservazione continua per i detenuti in crisi suicidaria, ed un uso appropriato dei mezzi di contenzione fisica come ultima modalità di controllare pazienti autolesionisti acuti.
- I detenuti con disturbi mentali che necessitano di cure psichiatriche devono essere trattati (con interventi farmacologici e psicosociali) e tenuti sotto stretta osservazione.
- Sviluppo di risorse interne o collegamenti con i servizi di igiene mentale di comunità esterni sufficienti per assicurare l’accesso alle cure psichiatriche quando sia necessario per un’ulteriore valutazione e trattamento.
- Strategie di “debriefing” quando avvengono casi di suicidio per migliorare in futuro il rilevamento dei tentativi, l’osservazione dei detenuti e la loro gestione nelle carceri».