Temi del Blog
SCOPRI I NOSTRI CORSI
-
Psicologo esperto ausiliario della Polizia Giudiziaria (PG) in fase di indagini preliminari
€77,40-€129,00
€129,00-€129,00
Il #MetodoScotland. Comprendere il #femminicidio e la #violenzadomestica per rafforzare la protezione e favorire il cambiamento

Il #MetodoScotland. Comprendere il #femminicidio e la #violenzadomestica per rafforzare la protezione e favorire il cambiamento
Condividi questo articolo:
Giulio Palma
Avvocato Penalista – Diritto Penale di impresa – Digital Forensic Analyst & Cybersecurity, Cybercrimes investigations
Introduzione
Anche se ne parla quasi ogni giorno, nelle trasmissioni televisive, sui social, nei convegni, se tanti scrivono e commentano i tragici ed efferati fatti di cronaca, rimane fondamentale continuare a portare avanti la discussione perché quello che succede non può e non deve passare inosservato, non può comportare alcuna assuefazione o rassegnazione perché non parlarne significherebbe rendersi complici. Non possiamo fare ciò che nei paesi anglosassoni viene definito “sweep under the rug” che significa “nascondere qualcosa di dannoso o spiacevole sotto il tappeto e mantenerlo segreto”.
Ognuno di noi può e deve cercare di migliorare almeno un po’ il mondo è la realtà che lo circonda.
Madre Teresa di Calcutta in una celebre preghiera, affermava: “Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe”.
Cosa può fare la politica?
Certamente dare risposte più tempestive riconoscendo unanimemente l’urgenza sociale, ma anche riconoscere espressamente che i #femminicidi e la #violenza domestica contro le donne e le ragazze sono forme di violenza contro il genere debole e indifeso che tante volte non e’ assistito con adeguata competenza e accuratezza.
Il femminicidio, quindi l’uccisione intenzionale di donne a causa del loro genere, è una questione profondamente inquietante e pervasiva che continua ad affliggere la società moderna.
Questa riflessione si propone di approfondire gli aspetti diversi della violenza di genere e le sue implicazioni nella società contemporanea, per cercare di fare luce su questa oscura realtà.
La violenza domestica costituisce un modello di comportamenti abusivi all’interno delle relazioni intime che impatta in modo profondo e duraturo sugli individui e sulle comunità. Per affrontare questi problemi in modo efficace, è essenziale comprenderne quindi la portata e le cause profonde.
Il femminicidio e la violenza domestica affliggono le società di tutto il mondo.
Occorre approfondire l’intricata relazione tra queste forme di violenza di genere e i fattori economici. E’ innegabile infatti che vi sia una stretta correlazione tra povertà, disuguaglianza, dipendenza economica e abusi, molestie, violenza e femminicidi perpetrati tramite il controllo finanziario della vittima.
Il significato del #femminicidio
Questo termine ormai tristemente noto, si è affermato negli ultimi anni, facendo luce su una forma specifica di violenza di genere e ricomprende varie condotte tra cui violenza domestica, delitti d’onore, omicidi legati alla dote, tratta di esseri umani e violenza sessuale, fino a provocare la morte di donne. Ciò che distingue il femminicidio è che affonda le sue radici nella discriminazione di genere e perpetua le disuguaglianze di genere. Comprendere le diverse forme di femminicidio è essenziale per cogliere la profondità del problema e sviluppare strategie efficaci di prevenzione.
Le cause del femminicidio e della violenza domestica
E’ importante quindi comprenderne la vera natura per affrontare in modo efficace il fenomeno.
I fattori economici, come la povertà e la disuguaglianza sono spesso condizioni facilitanti o terreno fertile per la violenza domestica e il femminicidio. Nelle comunità povere, l’accesso limitato alle risorse, all’istruzione e alle opportunità di lavoro può esacerbare le tensioni all’interno delle famiglie, portando alla violenza contro i soggetti più vulnerabili come le donne o i minori.
La disuguaglianza economica amplifica gli squilibri di potere all’interno delle relazioni. Quando un partner detiene un potere economico significativamente maggiore rispetto all’altro, si può verificare un atteggiamento di controllo e manipolazione, favorendo un ambiente permeabile agli abusi.
La dipendenza economica e il controllo finanziario sono strumenti che inducono in soggezione le vittime. Molte donne dipendono economicamente dai propri partner a causa di sistemi legislativi e sociali che non garantiscono pari opportunità di lavoro, conciliazione dei tempi di cura della famiglia con il lavoro, facilitazioni e supporti per svolgere ruoli genitoriali o di accudimento di figli minori o genitori anziani. Questa dipendenza può intrappolare le donne in relazioni tossiche e violente, poiché allontanarsi dal partner violento può significare perdere il sostegno finanziario.
Il controllo finanziario è un’arma molto spesso utilizzata dagli autori di abusi e violenze domestiche che in tal modo possono trattenere denaro, vietare l’accesso a conti correnti comuni o sabotare il lavoro o l’istruzione della vittima per mantenere il controllo su di essa e scoraggiare l’abbandono.
I fattori economici giocano anche un ruolo determinante sul fronte psicologico. Gli autori di abusi possono infatti sminuire le vittime perché incapaci di contribuire economicamente ai bisogni della famiglia, denigrazione per assenza di apporti o contributi finanziari, sminuendo le loro capacità, causando disagio emotivo e insicurezza. L’abuso economico può estendersi sino allo stalking e alle molestie, sia online che offline. Attraverso la tecnologia gli autori di abusi possono monitorare e controllare le vittime, isolandole ulteriormente dalle reti di supporto.
L’impatto nella società moderna
La persistenza nel terzo millennio di questa piaga sociale, sottolinea la rilevanza nel mondo moderno di una cultura che perpetua le forme di disuguaglianza di genere, la persistenza di norme patriarcali e di una sub -cultura intrisa di stereotipi sessisti.
La violenza di genere prospera nelle società in cui la discriminazione basata sul genere si reitera nei modelli educativi, rendendola una preoccupazione urgente che non può essere più ignorata nonostante i notevoli progressi che pure ci sono stati nelle legislazioni e nelle politiche culturali.
Occorre però un approccio globale per combattere questi fenomeni tra cui la necessità di riforme legislative, miglioramenti nell’applicazione delle leggi, servizi di supporto, istruzione e specializzazione, collaborazione internazionale.
Il quadro giuridico
Esplorare il quadro giuridico, le leggi e i regolamenti esistenti in tema di femminicidio e violenza domestica è essenziale per comprendere come la nostra società affronta il problema.
In questo articolo, analizzeremo in dettaglio le normative e i provvedimenti che sono stati introdotti in molti Paesi per combattere il femminicidio e la violenza domestica, al fine di avere uno sguardo comparato sulle diverse soluzioni adottate per proteggere le vittime, perseguire gli aggressori e prevenire ulteriori abusi.
Il femminicidio e la violenza domestica sono sfide globali che richiedono risposte giuridiche forti e strutturali.
La definizione giuridica di #femminicidio e #violenzadomestica varia da paese a paese, ma molte nazioni hanno adottato leggi specifiche per riconoscere e affrontare questi fenomeni. Le varie normative stabiliscono chiaramente cosa costituisce un crimine di femminicidio o violenza domestica e forniscono gli strumenti per le azioni legali, prevedendo pene severe per coloro che commettono omicidi intenzionali di donne a causa del loro genere.
In generale le normative in tema di violenza domestica disciplinano una gamma più ampia di abusi all’interno delle relazioni domestiche, tra cui abusi fisici, psicologici ed emotivi e possono includere provvedimenti per la protezione delle vittime, come ordinanze restrittive contro gli aggressori.
Il quadro giuridico spesso include anche provvedimenti per la protezione delle vittime tra cui rifugi sicuri, consulenza psicologica e supporto legale e l’obbligo per le forze dell’ordine, di rispondere prontamente alle chiamate di emergenza delle vittime.
In generale le normative contro il femminicidio e la violenza domestica stabiliscono pene rigorose per gli aggressori per incoraggiare le #vittime a denunciare gli abusi.
Le indagini e i processi penali devono essere condotti in modo efficace per garantire che gli aggressori siano puniti ma le leggi non si limitano alla punizione, in quanto spesso includono anche provvedimenti per la prevenzione e la sensibilizzazione.
I progetti educativi e di sensibilizzazione mirano a cambiare le norme sociali e a prevenire la violenza di genere, ad esempio attraverso campagne mediatiche, programmi educativi nelle scuole e formazione per professionisti della salute e delle #forzedell’ordine.
Nonostante i progressi fatti, la piena attuazione delle leggi contro il femminicidio e la violenza domestica costituisce ancora una grande sfida delle società contemporanee a causa di un gran numero di abusi e violenze sommerse e non denunciate, l’accesso limitato ai servizi di supporto, la mancanza di risorse finanziarie per la formazione per le forze dell’ordine e i professionisti della salute.
Proposta di legislazione (Ddl)
Per migliorare la protezione delle vittime, sono allo studio una serie di modifiche legislative che includono sanzioni più severe per i colpevoli, ordinanze restrittive più incisive e definizioni legali più dettagliate di violenza domestica e femminicidio.
Tra tali modifiche vi è il disegno di legge n. 2530, approvato il 3 dicembre 2021 dal Consiglio dei Ministri su proposta delle Ministre per le pari opportunità, dell’Interno e della Giustizia, recante “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica ”. Il testo è stato presentato al Senato il 16 febbraio 2022 e assegnato alla Commissione giustizia il 3 marzo scorso.
Tra le novità più significative in materia di violenza domestica si rinviene quella riguardante la possibilità di disporre di forme di vigilanza dinamica da parte del prefetto, quella riguardante l’applicazione e la violazione delle misure cautelari da parte del reo nonché quella relativa alla sospensione condizionale della pena.
È noto che ai sensi dell’art. 362 c.p.p., il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.
Nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti in famiglia, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, tratta di persone, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni e atti persecutori, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile: tale istituto richiama l’intervento legislativo effettuato con legge 172 del 2012 attuativa della Convenzione di Lanzarote.
Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizioni di particolare vulnerabilità come previsto dall’art. 1 del d.lgs. 212/2015.
La Decisione quadro del Consiglio d’Europa del 15 marzo 2011 relativa alla posizione della vittima nel processo penale nonché numerosi atti internazionali costituiscono il riferimento normativo per la definizione di “vittima vulnerabile” intesa come chi, per le caratteristiche di natura personale (minore o infermo di mente) o per il tipo di violenza a cui è stato sottoposto, ha subito un trauma o come chi, quale vittima del reato, ha vissuto una condizione di sofferenza psicologica.
Oltre che nella legislazione internazionale ed europea, il nucleo semantico dell’espressione “#vittimavulnerabile” trova la sua fonte in alcuni passaggi della sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2005 che lega il concetto di vulnerabilità alla condizione di infermità mentale.
A seguito dell’entrata in vigore della L. 69/2019 quando si procede per uno dei delitti di violenza domestica e di genere previsti dagli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis c.p., ovvero dagli artt. 582e 583 quinques c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli art. 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1, n.1, e comma 2, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato.
Il Pubblico Ministero può soprassedere all’immediata escussione quando: – trattasi di minorenne, (particolare vulnerabilità della vittima – art. 90 quater c.p.p.-) e le particolari modalità di escussione protetta (artt. 351, c.1 ter e 362, c. 1 bis c.p.p.) possono comportare possibili complessità organizzative, temporalmente incompatibili con il termine di tre giorni previsto dalla legge; – analogamente vi possono essere le stesse ragioni di complessità organizzative nel caso di persona maggiorenne particolarmente “vulnerabile”, così come prevede la norma quando parla di esigenza di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della vittima; – nel caso di vittima maggiorenne non particolarmente vulnerabile, ugualmente vi possono essere esigenze legate alla riservatezza delle indagini che fanno optare per una lettura derogatoria; – quando la persona offesa minorenne o maggiorenne particolarmente vulnerabile sia già stata sentita dalla P.G. in modo esaustivo e sufficiente al momento della denuncia.
Il P.M. può valutare persino dannosa una nuova escussione della vittima a così breve distanza dalla prima: si vuole evitare una “#vittimizzazionesecondaria” a carico della persona offesa dal reato, la quale inevitabilmente si troverà in una situazione di forte disagio emotivo nel ripercorrere e nel descrivere nuovamente i fatti subiti.
La finalità della riforma è stata quella di evitare che eventuali stasi, nell’acquisizione e nell’iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza.
Gli obiettivi sono stati quelli di garantire l’immediata instaurazione e progressione del procedimento penale al fine di pervenire, ove necessario, nel più breve tempo possibile all’adozione di provvedimenti “protettivi o di non avvicinamento” e quello di impedire che ingiustificabili stasi procedimentali possano porre ulteriormente in pericolo la vita e l’incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere.
Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine ma, ai sensi dell’art. 370 c.p.p., può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificatamente delegati, ivi compresi gli interrogatori.
A seguito dell’entrata in vigore della l. 69/2019, se si tratta di uno dei delitti di violenza domestica e di genere previsti dagli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter c.p. ovvero dagli artt. 582 e 583 quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, comma 1, nn. 2, 5, 5.1, e 577, comma 1, n.1, e comma 2, del medesimo codice, la #poliziagiudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.
In questi casi la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell’attività nelle forme e con le modalità previste dall’art. 357 c.p.p.
Dunque la legge di riforma, integrando l’art. 370 c.p.p., ha imposto alla polizia giudiziaria un canale preferenziale nella trattazione delle indagini delegate dal pubblico ministero che riguardino i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza; anche in questo caso è stata introdotta una presunzione legale di urgenza per le indagini delegate dal pubblico ministero in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Il disegno di legge prevede all’art. 11, inserendo l’art. 3.1 alla legge n. 119/2013, che nei procedimenti per i delitti di cui all’art. 362, comma 1 ter, c.p.p. commessi in ambito di violenza domestica, l’organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, deve dare comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell’ambito delle riunioni di coordinamento dell’Ufficio provinciale per la sicurezza personale, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale a tutela della persona offesa.
Il disegno di legge, inoltre, prevede all’art. 9 che nei medesimi procedimenti, l’estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 dell’art. 362 c.p.p. o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che può adottare misure di vigilanza dinamica che sono anche in tal caso sottoposte a revisione trimestrale.
Come precisato dalla relazione tecnica, la vigilanza dinamica consente una mirata attenzione delle pattuglie operative nelle zone frequentate dai soggetti individuati come sensibili, nell’ambito di apposite modulazioni di percorsi e passaggi delle stesse.
Relativamente a quanto previsto in materia di misure cautelari, il legislatore ha arricchito il catalogo delle medesime ed ha predisposto diverse forme di tutela cautelare della persona offesa da reati riconducibili alla violenza di genere e più nello specifico alla violenza domestica.
In particolare, con l. 4 aprile 2001, n. 154 è stato introdotto l’ art. 282-bis rubricato «Allontanamento dalla casa familiare», misura cautelare applicabile laddove «vi siano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica e psichica della persona offesa» legata da rapporti di coniugio, di parentela, di convivenza o comunque affettivi, presenti o passati, alla persona accusata.
Tale misura prevede che con il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prescrive al destinatario di lasciare immediatamente la casa familiare, di non farvi rientro e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede; qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, il giudice può inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro.
Allo scopo di offrire una tutela anche di tipo economico alla persona offesa è peraltro previsto che il giudice, su richiesta del pubblico ministero, possa ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, in conseguenza della misura cautelare disposta, rimangano prive dei necessari mezzi di sostentamento. Nel determinare l’importo dell’assegno si tiene conto delle circostanze e dei redditi dell’obbligato ed è possibile ordinare, se necessario, che l’assegno venga versato direttamente al beneficiario dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante.
La medesima norma stabilisce però che la misura deve essere revocata – ai sensi del co. 5 – allorché la convivenza riprenda: sul punto andrebbe chiarito come possa la coabitazione tra vittima ed indagato riavviarsi senza che si rilevi una violazione dell’ordinanza di allontanamento, violazione che dovrebbe, oltre che originare un aggravio della misura, essere sanzionata alla luce dell’art. 387 bis introdotto dal #codicerosso.
Tale misura cautelare risulta applicabile anche alle fattispecie criminose estranee alla sfera familiare però riacquista la sua esclusività in quanto al c.6 prevede che “qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli artt. 570, 571, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti previsti dall’art. 280 c.p.p. ovvero al di fuori della cornice edittale per la quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 3 anni.
La ragione della deroga all’art. 280 c.p.p. deve rinvenirsi nella volontà di applicare la misura cautelare in esame anche ai reati a pena edittale inferiore nel massimo a tre anni ricomprendendo così la violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570, 571 c.p. e le ipotesi più lievi dei delitti riguardanti la sfera sessuale.
Il legislatore del 2009 introduce la misura coercitiva non custodiale ex art. 282 ter c.p.p. con cui il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
Una novità introdotta dalla l. 69/2019 si sostanzia nella possibilità di disporre l’applicazione di particolari modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico) già prevista dall’art. 275 bis c.p.p. per la misura degli arresti domiciliari e dall’art. 282 bis c.p.p. per quella dell’allontanamento dalla casa familiare.
L’art. 2 del disegno di legge interviene altresì sulla disciplina delle particolari modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all’articolo 275-bis del codice di procedura penale: in particolare, viene prevista l’applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o nei casi previsti dagli articoli artt. 282-bis (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) e 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), nonché, con riferimento a queste ultime due misure, la possibilità di applicare una misura più grave, anche congiunta, nel caso di mancato consenso dell’imputato all’applicazione del mezzo di controllo elettronico.
L’art. 282 ter prevede al comma 2 che qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può porre i medesimi divieti anche con riferimento ai prossimi congiunti della vittima o ai suoi conviventi o a persone legate a essa da una relazione affettiva.
I provvedimenti con i quali vengono applicate le misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore e ai servizi socioassistenziali del territorio. Con la predetta comunicazione, la persona offesa è informata della facoltà di richiedere l’emissione di un ordine di protezione europeo.
La l. n. 119 del 2013 ha altresì inserito nel codice di procedura penale il nuovo art. 384-bis rubricato «Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare»: non sembrano esservi dubbi sul fatto che si tratti di una misura pre-cautelare in considerazione della sua inclusione nell’ambito del titolo VI del libro V del codice di rito, dedicato all’arresto in flagranza ed al fermo, e della fisionomia stessa del nuovo istituto.
L’introduzione della suddetta misura pre-cautelare è stata accompagnata dalla previsione di una nuova ipotesi di giudizio direttissimo legata alla convalida dibattimentale dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, ipotesi che tuttavia non può non destare qualche perplessità rispetto alla collocazione sistematica posto che il legislatore ha inserito la nuova fattispecie di rito direttissimo all’interno del co. 5 dell’art. 449 c.p.p., concernente il giudizio instaurato a seguito di confessione, anziché, come forse sarebbe stato più opportuno, all’interno del co. 1 della medesima norma, riguardante il caso di giudizio speciale instaurato nelle quarantotto ore dall’arresto.
Con l’intento di dare attuazione all’art. 53 della Convenzione di Istanbul, nella parte in cui dispone che la violazione delle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento e comunicazione con la vittima ad opera del destinatario deve essere sanzionata penalmente o comunque deve dare luogo a «sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive», l’art. 4 della legge n. 69 del 2019 ha introdotto l’art. 387-bis c.p., rubricato «Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa», secondo cui «chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
È stato rilevato, a seguito dell’introduzione della norma, un difetto di coordinamento normativo tra l’introduzione dell’obbligatorietà dell’arresto in flagranza per il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla p.o. di cui all’ art. 387-bis c.p. e le norme che disciplinano le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali, le quali non consentono l’adozione di alcuna misura cautelare per tale reato in ragione dei suoi limiti edittali inferiori ai requisiti di pena necessari per l’applicabilità delle misure coercitive (art. 280 c.p.p.).
Tale situazione comporta l’immediata liberazione degli arrestati, senza poter procedere all’applicazione di alcuna misura coercitiva nei loro confronti.
È necessario ricordare, infatti, che il codice di procedura penale indica i casi in cui l’arresto è obbligatorio (art. 380 c.p.p.) e quelli in cui è facoltativo (art. 381 c.p.p.).
Quanto al primo, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni nonché negli altri casi elencati nella norma.
In base all’art. 381 c.p.p. invece, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. La norma contempla anche una possibilità di deroga a tale regola generale nel senso che l’arresto in flagranza è ammesso in via facoltativa pure per reati con pene inferiori allorché rientrino nell’elenco di cui al co. 2 dell’articolo 381 c.p.p.: tuttavia il reato ex art. 387 bis c.p. non è compreso in siffatto catalogo.
Per risolvere tale aporia il disegno di legge intende infatti modificare l’art. 391, comma 5, c.p.p. che, in alcuni casi, consente l’applicazione delle misure cautelari anche fuori dai limiti di pena previsi dagli artt. 274, comma 1, lett. c) e 280 c.p.p. : si vuole aggiungere alle ipotesi di cui all’art. 381, comma 2, c.p.p., l’ipotesi dei delitti, consumati o tentati, per cui sia disposto l’arresto obbligatorio in flagranza di cui all’art. 380, comma 2, c.p.p. tra i quali rientra, appunto, proprio il reato di cui all’art. 387-bis c.p alla lettera l-ter).
Lo stesso art. 1 d.d.l. inserisce, infine, nell’art. 391, comma 5, c.p.p. anche un ulteriore caso in cui sarà possibile applicare le misure cautelari fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274 e 280 c.p.p., ossia quando si farà ricorso alla nuova ipotesi di fermo del P.M. o di p.g. prevista dall’introducendo comma 1-bis dell’art. 384 c.p.p.
Quanto alle modifiche di cui all’art. 387 bis, in primo luogo l’art. 12 ddl precisa che “nei casi di cui all’art. 387 bis del #Codicepenale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale sulla base di video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”.
In secondo luogo, l’art. 8 del disegno di legge prevede che venga aggiunto dopo il primo comma il seguente:” La stessa pena si applica a chi elude l’ordine di protezione previsto dall’art. 342 ter, primo comma, del #Codicecivile, ovvero un provvedimento di uguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
In tal modo, l’art. 8 d.d.l. equipara la violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari emessi dal giudice civile di cui all’art. 342-ter c.c. alla violazione degli analoghi provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento alla p.o. adottati dal giudice penale ex artt. 282- 282-ter c.p.p. (ed agli ordini di allontanamento d’urgenza disposti dalla p.g. ai sensi dell’art. 384-bis c.p.p.), prevedendo per entrambe le ipotesi l’integrazione del reato di cui all’art. 387-bis c.p.
Relativamente alla sospensione condizionale della pena, è noto che essa sospende l’esecuzione della sanzione per cinque anni in caso di condanna per delitto e per due anni in caso di condanna per contravvenzione.
Se entro tale termine il reo non commette un reato della stessa indole ed assolve agli obblighi che gli sono imposti, il reato è estinto e non si procederà all’esecuzione della pena; viceversa, se il reo continua a delinquere dovrà scontare insieme la vecchia e la nuova pena.
I presupposti per la concessione sono: – una condanna a pena detentiva ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta a pena detentiva, non superi complessivamente il limite di due anni di arresto o di reclusione, due anni e sei mesi, nel caso di soggetto maggiore degli anni 18 ma minore degli anni 21, due anni e sei mesi nel caso di soggetto ultrasettantenne, tre anni nel caso di minore degli anni 18.
La l. 11 giugno 2004, n. 145 ha introdotto un’ulteriore ipotesi in cui può essere concessa la sospensione condizionale della pena: è il caso in cui sia pronunciata condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore ai due anni, quando la pena nel complesso ragguagliata ex art. 135 c.p., sia comunque superiore al limite di due anni.
Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno, l’art. 163, comma 4, c.p., recentemente modificato dal d.lgs. 150/2022, consente al giudice di sospenderla per il termine di un anno quando il colpevole, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, abbia integralmente adempiuto agli obblighi risarcitori oppure si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
L’art. 165 c.p. prevede che la concessione della sospensione condizionale della pena possa essere subordinata: – all’adempimento, entro il termine assegnato dal giudice, delle obbligazioni civili derivanti dalla condanna; – alla pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno; – alla cancellazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; – alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività (purché vi sia il consenso del condannato e per un tempo non superiore alla durata della pena sospesa).
L’art. 165 c.2 c.p. prevede la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena anche a chi ne abbia già usufruito una volta, purché la pena da infliggere con la seconda condanna, cumulata a quella già sospesa, non superi i limiti dell’art. 163 c.p.
L’articolo 7 del disegno di legge interviene sulla disciplina della sospensione condizionale della pena nel caso di reati di violenza domestica.
La legge n. 69 del 2019 (c.d. #CodiceRosso), con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere, subordina la concessione del beneficio alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.
In particolare, l’art.165, quinto comma, c.p., prevede che: «Nei casi di condanna per il delitto previsto dall’articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.».
Come precisato dalla relazione tecnica al disegno di legge, la norma, tuttavia, non individua alcuna istituzione pubblica che fornisca al giudice un aiuto finalizzato ad individuare gli enti o le associazioni presso cui svolgere i programmi riabilitativi, sia per verificare l’effettivo svolgimento dei percorsi di recupero.
Il disegno di legge, intervenendo sul comma 5 dell’art.165 c.p., individua l’Ufficio di esecuzione penale esterna come struttura preposta a tali funzioni.
Prevede, inoltre, che qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione, ai sensi dell’articolo 168, primo comma, n. 1, c.p.
Con il comma 2 dell’art. 7 del disegno di legge viene modificato l’art. 18-bis disp. att. c.p., il quale dispone che la sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, sia comunicata all’ufficio di esecuzione penale esterna, affinché lo stesso accerti l’effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero; si aggiunge che gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero debbano dare immediata comunicazione all’ufficio di esecuzione penale esterna di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero.
Il Metodo Scotland
Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto in Italia una “disciplina organica della #giustiziariparativa”, destinata ad affiancarsi, senza sostituirsi, al processo e all’esecuzione penale. Tale normativa si presenta in linea con la Direttiva UE n.29 del 2012 in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e con la Dichiarazione di Venezia adottata dalla Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa il 13 dicembre 2021.
Tale giustizia riparativa consiste in un programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti da reato, con l’aiuto di un terzo imparziale denominato “mediatore”.
La disciplina prevede la possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, in ogni stato e grado del procedimento, anche in fase esecutiva o dopo l’integrale esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
È previsto l’obbligo in capo all’autorità giudiziaria di informare le parti circa la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili.
Al termine del programma il mediatore redige una relazione riepilogativa delle attività svolte e dell’esito raggiunto, che viene trasmessa all’autorità giudiziaria; è necessario precisare che, come previsto dall’art. 58 c.2, in ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa.
La nozione di esito riparativo è delineata dall’art. 42 come “qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti”.
Un esempio internazionale di giustizia di riparativa è il metodo inglese c.d. “#metodoScotland” promosso da Patricia Scotland, avvocato, ex Guardasigilli del Governo laburista, fondatrice e presidente della EDV (Global Foundation for the Elimination of Domestic Violence).
Patricia Scotland, tra il 2003 e il 2010, ha promosso e coordinato tale progetto operativo contro la violenza domestica in Gran Bretagna grazie al quale è diminuito grandemente il numero delle vittime di questo fenomeno criminoso.
Nella città di Londra, nel periodo indicato, gli omicidi di donne sono diminuiti circa del 64%, grazie ad un sistema di coordinamento di tutti gli istituti già presenti nella maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali. Il sistema, infatti, è basato su tre elementi: cooperazione tra sistema giudiziario, polizia e servizi medico-sanitari, incremento economico (PIL) derivante dalla diminuzione delle assenze dal lavoro causate da situazioni di violenza e promozione di politiche sociali.
Oltre la riduzione dei tassi di omicidio, si è avuta una conseguente riduzione delle carcerazioni e l’utilizzo di misure alternative alla detenzione come programmi di supervisione comunitaria: vi è stata, dunque, una promozione della giustizia riparativa con la seguente assunzione di responsabilità da parte del reo, maggiore coinvolgimento nel processo penale e riparazione del danno causato alle vittime nonché sviluppo delle comunità e miglioramento della sicurezza pubblica.
Secondo il protocollo di intesa tra Servizi sociali, medici, avvocati e operatori di polizia giudiziaria, la persona offesa viene assistita per un periodo di circa tre mesi e accede ad un vero e proprio Programma di assistenza e reinserimento sociale.
Le principali misure adottate si sostanziano, in primis, nell’allontanamento fisico della vittima dal luogo in cui si consuma la violenza che è generalmente costituita dalle mura domestiche, la seguente sistemazione in un alloggio pubblico o in un’abitazione privata.
Vengono, inoltre, affiancati alla vittima i tutor e gli IDVAR (Indipendent domestic violence adviser); nel progetto sono coinvolte, altresì, le aziende per fare in modo che le donne possano continuare a lavorare senza perdere la propria indipendenza economica.
Ci si chiede se in Italia tale metodo abbia avuto qualche forma di incidenza. Nel 2013 Patricia Scotland ha siglato un accordo con l’Università di Milano-Bicocca con lo scopo di sensibilizzare e introdurre, anche nel sistema giudiziario italiano, il metodo Scotland, come già sperimentato in Spagna e in Nuova Zelanda.
Marina Calloni, docente di Filosofia Politica e sociale presso l’Università di Milano-Bicocca è stata nominata ambasciatrice della Global Foundation for the Elimination of Domestic Violence ed, al fine di promuovere l’utilizzo del metodo, è stato fondato un progetto l’EDV Italy Project che ha la funzione primaria di porre in essere un lavoro di ricerca e sensibilizzare le istituzioni.
Applicazione della legge e risposta
Le forze dell’ordine svolgono un ruolo fondamentale nell’affrontare la violenza domestica ed il femminicidio. Il DDl prevede una formazione mirata della polizia sulla gestione dei casi di violenza domestica, il miglioramento dei tempi di risposta alle chiamate di emergenza e il rafforzamento della cooperazione tra le forze dell’ordine e i servizi di supporto.
L’applicazione della legge e la pronta risposta nei casi di femminicidio e violenza domestica in Italia, sono temi di grande rilevanza. Come affrontano le autorità italiane il fenomeno?
Dalla legislazione alla risposta immediata alle vittime
In Italia, il quadro giuridico contro il femminicidio e la violenza domestica è costituito da leggi specifiche. La Legge 119/2013 definisce il #femminicidio come omicidio di una donna commesso in circostanze legate al suo genere. La Legge 154/2001 affronta la violenza domestica e prevede ordini restrittivi contro gli aggressori.
Le autorità italiane prevedono una gamma di servizi per la protezione delle vittime di femminicidio e violenza domestica: ci sono rifugi sicuri dove le vittime possono trovare protezione temporanea, assistenza legale e supporto psicologico. Inoltre, è possibile richiedere ordinanze restrittive contro gli aggressori per limitare il loro contatto con le vittime.
Le forze dell’ordine italiane hanno il compito di rispondere prontamente ai casi di violenza domestica e femminicidio, mediante l’apertura di indagini, l’arresto degli aggressori e il recupero delle prove. Gli agenti di polizia devono essere addestrati per gestire tali situazioni sensibili e garantire che le vittime ricevano assistenza immediata.
In Italia, sono in corso sforzi significativi per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere e per prevenirla. Ci sono campagne mediatiche, programmi educativi nelle scuole e formazione per professionisti della salute e delle forze dell’ordine. Si cerca di cambiare le norme sociali e promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza di genere.
Nonostante i progressi però, i numeri delle violenze in Italia sono ancora inaccettabili. Ecco perché fondamentale è il ruolo delle organizzazioni della società civile per cercare di colmare queste lacune.
Servizi di supporto
Creare spazi sicuri per le vittime è fondamentale. Questa proposta di legge raccomanda di istituire rifugi e centri di supporto attrezzati per fornire assistenza immediata, consulenza, assistenza legale e riabilitazione a lungo termine.
Gli articoli e le ricerche scientifiche sul femminicidio e sulla violenza domestica indicano chiaramente che i servizi sociali di supporto, rivestono un ruolo cruciale nella prevenzione di questi tragici fenomeni. Contribuendo a ridurre il rischio di femminicidio e violenza domestica.
Prima di esaminare l’importanza dei servizi sociali di supporto, è importante definirli chiaramente: essi includono rifugi per vittime di violenza domestica, linee telefoniche di emergenza, consulenza psicologica, supporto legale e programmi di formazione per le vittime. Si può dire che giocano un ruolo fondamentale nel riconoscere e affrontare la violenza domestica prima che si trasformi in femminicidio.
Infatti, le donne che cercano di sfuggire a situazioni di violenza domestica spesso hanno bisogno di un luogo dove poter rifugiarsi senza paura. Questi ambienti protetti offrono riparo, sicurezza e consentono alle vittime di riprendersi e pianificare il proprio futuro.
La violenza domestica può causare gravi traumi emotivi e psicologici alle vittime. I servizi sociali forniscono consulenza e supporto psicologico per aiutare le vittime a far fronte ai traumi subiti, a recuperare la propria autostima e il senso di controllo sulla propria vita.
Molte vittime di violenza domestica hanno bisogno di assistenza legale per ottenere ordinanze restrittive contro gli aggressori, gestire questioni di custodia dei figli e affrontare questioni finanziarie. I servizi sociali o i centri anti violenza offrono anche supporto legale per garantire che le vittime abbiano accesso ai diritti legali e alla giustizia.
I servizi sociali svolgono inoltre un ruolo fondamentale nella prevenzione attraverso programmi di formazione che educano le donne sulle dinamiche disfunzionali, abusive, sulla gestione del rischio e sulla creazione di piani di sicurezza. Inoltre, possono coinvolgere la comunità nel riconoscere e affrontare la violenza domestica.
Infatti oltre a fornire supporto diretto alle vittime, i servizi sociali promuovono la sensibilizzazione e l’educazione nella società. Campagne di sensibilizzazione e programmi educativi nelle scuole possono contribuire a promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza di genere.
Purtroppo, anche i servizi sociali di supporto devono fare i conti con la disponibilità limitata di risorse finanziarie e la necessità di un maggiore coinvolgimento della comunità. Ecco perché è necessario un impegno continuo per migliorare l’accesso ai servizi e garantire che siano adeguatamente finanziati.
Educazione e Consapevolezza
L’educazione e la consapevolezza riguardo al tema del femminicidio e della violenza domestica sono essenziali per combattere questi gravi fenomeni. Prevenire la violenza domestica e il femminicidio richiede un cambiamento degli atteggiamenti dei singoli e dell’intera società.
Dovrebbero essere sviluppati programmi educativi e campagne di sensibilizzazione per abbattere gli stereotipi, promuovere l’uguaglianza di genere ed educare i cittadini a riconoscere e a denunciare gli abusi.
Il femminicidio e la violenza domestica rappresentano una sfida nazionale che richiede un approccio multidisciplinare per essere affrontata con successo. L’educazione e la consapevolezza sono pilastri fondamentali di questo approccio, in quanto aiutano a cambiare le norme, a riconoscere i segnali precoci di violenza e a promuovere il rispetto e l’uguaglianza di genere.
La prevenzione e la sensibilizzazione sono essenziali per avvisare la violenza di genere. Le campagne di sensibilizzazione possono raggiungere un vasto pubblico attraverso i media, educando sulle dinamiche abusive, sull’importanza del consenso e sulle risorse disponibili per le vittime. La prevenzione inizia con l’educazione nelle scuole, insegnando ai giovani il rispetto reciproco e la consapevolezza delle conseguenze della violenza domestica.
L’introduzione di programmi educativi sul tema della violenza domestica nelle scuole è fondamentale. Questi programmi insegnano ai giovani a riconoscere segnali precoci di abuso, a promuovere relazioni sane e rispettose e a fornire supporto alle vittime. Solo una educazione di questo tipo può contribuire a interrompere il ciclo di violenza prima che diventi irreversibile.
L’educazione sulla violenza di genere dovrebbe includere anche la promozione dell’uguaglianza di genere. Questo significa sfidare stereotipi di genere dannosi e promuovere l’idea che uomini e donne abbiano gli stessi diritti e opportunità. L’uguaglianza di genere è fondamentale per affrontare le radici della violenza domestica.
L’informazione e la consapevolezza riguardo al femminicidio e alla violenza domestica devono anche comprendere l’informazione sulle risorse disponibili per le vittime.
Le vittime devono sapere dove cercare aiuto e supporto, che siano rifugi, linee telefoniche di emergenza o servizi di consulenza. Queste informazioni possono essere vitali per chi cerca di sfuggire a situazioni abusive.
Il coinvolgimento della Comunità e di Associazioni non profit, società civile, gruppi religiosi e istituzioni locali è fondamentale per create sinergie, reti di supporto, collaborazione per promuovere iniziative di sensibilizzazione. L’interessamento della comunità è essenziale per creare un ambiente in cui la violenza di genere sia condannata e respinta in ogni sua forma e per creare una maggior sicurezza.
Raccolta e analisi dei dati
Altro aspetto fondamentale è la raccolta accurata dei dati per comprendere la portata della violenza domestica e del femminicidio. Questa proposta di legge, suggerisce l’implementazione di un solido sistema per il monitoraggio e l’analisi dei casi, che possa informare le decisioni politiche e l’allocazione delle risorse. L’importanza dei dati statistici nella ricerca sui fenomeni di femminicidio e violenza domestica è innegabile. Questi dati rivelano l’entità del problema, identificano tendenze, sostengono politiche efficaci, promuovono la consapevolezza, alimentano la ricerca accademica e guidano gli sforzi di prevenzione e intervento. Per affrontare questi problemi in modo efficace, è essenziale conglobare, analizzare e utilizzare dati statistici accurati e aggiornati. Questi dati forniscono una panoramica completa della portata del problema, consentendo a ricercatori, policymaker e attivisti, di prendere decisioni informate per proteggere le vittime e prevenire futuri episodi di violenza.
La violenza domestica comprende una serie di comportamenti abusivi, come abuso fisico, psicologico ed emotivo, all’interno delle relazioni domestiche: la misurazione accurata di questi fenomeni richiede definizioni precise e criteri di raccolta di dati uniformi. I dati statistici rivelano l’entità del problema del femminicidio e della violenza domestica, forniscono informazioni sui tassi di incidenza, la gravità delle lesioni, le caratteristiche delle vittime e degli autori di violenza. Questi dati dimostrano che questi fenomeni non sono isolati, ma diffusi in tutto il mondo.
Lo studio e le ricerche possono determinare se i tassi di femminicidio e violenza domestica stanno aumentando o diminuendo, se ci sono differenze regionali o culturali significative e quali gruppi sono più vulnerabili. Queste informazioni sono cruciali per indirizzare le risorse e sviluppare strategie di prevenzione mirate. I dati statistici forniscono una base solida per lo sviluppo di politiche e leggi efficaci per contrastare il femminicidio e la violenza domestica. Le evidenze empiriche derivanti dai dati possono influenzare le decisioni dei legislatori e aiutare a introdurre riforme significative. Ad esempio, molte nazioni hanno adottato leggi più severe contro la violenza domestica basandosi su dati che dimostrano la sua diffusione e gravità.
La prevenzione e l’intervento efficaci, dipendono dalla comprensione dei dati. Gli operatori di servizi sociali, gli psicologi e gli avvocati possono utilizzare le informazioni raccolte per aiutare le vittime, sviluppare programmi di sostegno e migliorare l’accesso ai servizi. La tempestiva identificazione dei rischi è fondamentale per prevenire ulteriori episodi di violenza.
Solo attraverso questo impegno collettivo possiamo sperare di porre fine a una mattanza che continua a colpire molte donne.
Collaborazione internazionale
Si è già detto che femminicidio e la violenza domestica sono problemi globali. La collaborazione internazionale è vitale per condividere le migliori pratiche, coordinare gli sforzi e affrontare casi transfrontalieri. Dovrebbero essere quindi promossi i partenariati con organizzazioni internazionali e paesi vicini.
L’importanza della collaborazione internazionale nello studio, nella ricerca e nella raccolta di dati statistici sul fenomeno del femminicidio e della violenza domestica è cruciale per affrontare queste sfide in modo efficace.
Il femminicidio e la violenza domestica sono problemi diffusi che non conoscono confini nazionali.
Per affrontare queste gravi violazioni dei diritti umani, è necessaria una collaborazione internazionale che consenta di raccogliere dati accurati, condividere migliori pratiche e sviluppare strategie comuni di prevenzione e intervento.
La raccolta e la condivisione di dati statistici accurati sono fondamentali per monitorare l’entità e la portata del femminicidio e della violenza domestica. La collaborazione tra paesi consente di confrontare dati e tendenze, identificare disparità regionali e sviluppare strategie mirate. Inoltre, la condivisione di dati può facilitare la ricerca e l’analisi approfondite.
La cooperazione internazionale favorisce la ricerca congiunta e l’analisi approfondita dei fattori che contribuiscono al femminicidio e alla violenza domestica. Gli studi comparativi tra paesi possono rivelare modelli comuni e cause sottostanti. Questa conoscenza è fondamentale per sviluppare politiche e programmi di prevenzione più efficaci.
La collaborazione internazionale consente di identificare e condividere migliori pratiche nell’affrontare il femminicidio e la violenza domestica. Infatti, gli interventi di successo in un paese possono essere adattati e applicati in altre nazioni. Questa condivisione di conoscenze contribuisce a migliorare le risposte globali a questi problemi.
Lavorare insieme a livello internazionale consente di sensibilizzare l’opinione pubblica globale sulla gravità del femminicidio e della violenza domestica. Le organizzazioni internazionali possono svolgere un ruolo cruciale nell’elevare la consapevolezza su questi temi attraverso campagne mediatiche e advocacy presso i governi.
La cooperazione internazionale è fondamentale per promuovere e proteggere i diritti umani delle donne. Trattati internazionali come la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) forniscono linee guida per gli Stati membri nell’affrontare la violenza di genere. La collaborazione è necessaria per garantire che tali accordi siano rispettati e attuati in tutto il mondo.
Nonostante i vantaggi della collaborazione internazionale, ci sono criticità da affrontare, tra cui la protezione dei dati personali delle vittime, le differenze culturali nelle percezioni della violenza di genere e la necessità di risorse finanziarie per sostenere iniziative congiunte. Tuttavia, superare queste sfide è essenziale per un progresso significativo.
Finanziamenti
L’attuazione di questi cambiamenti richiede però molte risorse finanziarie. Questa proposta di legge delinea una stima di budget per varie iniziative, inclusi i servizi di supporto, campagne educative e miglioramenti delle forze dell’ordine. Le potenziali fonti di finanziamento includono stanziamenti governativi e contributi di organizzazioni non governative.
L’importanza dei finanziamenti pubblici a supporto della lotta contro il femminicidio e la violenza domestica è fondamentale per affrontare efficacemente questo grave problema sociale. Questi finanziamenti rappresentano un impegno tangibile da parte delle istituzioni e della società nel proteggere le vittime, prevenire la violenza e promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza di genere.
I finanziamenti pubblici sono cruciali in questa lotta.
Ecco alcune ragioni chiave:
-sostenere le vittime con finanziamenti pubblici consente di fornire supporto immediato alle vittime di violenza domestica e femminicidio. Questo può includere rifugi sicuri, servizi di consulenza, assistenza legale e supporto psicologico. Senza finanziamenti adeguati, queste risorse sarebbero limitate o inesistenti, lasciando molte vittime senza aiuto.
-i finanziamenti pubblici possono essere utilizzati per sviluppare e implementare programmi di prevenzione che possono includere educazione nelle scuole, campagne di sensibilizzazione pubblica e formazione per professionisti della salute e delle forze dell’ordine. La prevenzione è essenziale per interrompere il ciclo della violenza.
La ricerca sulla violenza domestica e il femminicidio è fondamentale per comprendere le cause sottostanti e identificare modelli di comportamento. I finanziamenti pubblici possono sostenere la ricerca accademica e istituzionale, contribuendo a informare politiche e interventi basati su evidenze. Inoltre, possono finanziare campagne di sensibilizzazione pubblica per promuovere una maggiore consapevolezza su questi problemi.
L’allocazione di risorse pubbliche consente di sviluppare e attuare leggi e politiche efficaci per affrontare il femminicidio e la violenza domestica. Queste leggi possono includere ordini di restrizione, norme contro il traffico di esseri umani e misure per garantire che gli autori di violenza siano perseguiti e puniti in modo adeguato.
Molte organizzazioni non profit si dedicano alla lotta contro la violenza domestica e il femminicidio. I finanziamenti pubblici possono essere fondamentali per sostenere il loro lavoro, garantendo che possano continuare a fornire servizi vitali alle vittime e partecipare attivamente alla promozione del cambiamento culturale.
I finanziamenti pubblici consentono di istituire sistemi di monitoraggio e valutazione o agenzie “Task Force” per misurare l’efficacia delle politiche e degli interventi. Questo permette di apportare miglioramenti e di adattare le strategie in base ai risultati ottenuti.
La lotta contro la violenza domestica e il femminicidio richiede la cooperazione di diverse agenzie e organizzazioni. I finanziamenti pubblici possono essere utilizzati per promuovere la collaborazione e la coordinazione tra questi attori, migliorando così l’efficacia complessiva degli sforzi.
È importante sottolineare che la violenza domestica e il femminicidio non sono solo questioni individuali, ma rappresentano una sfida sociale che richiede un impegno collettivo.
Attraverso i finanziamenti pubblici si mette in campo un impegno concreto per proteggere le donne e promuovere un cambiamento culturale che metta fine alla violenza di genere.
Tuttavia, è anche importante garantire che questi finanziamenti siano assegnati in modo efficace e trasparente, evitando sprechi e assicurando che raggiungano le vittime e le comunità più vulnerabili. Inoltre, è essenziale un costante monitoraggio e una valutazione delle politiche per assicurare che siano adattate alle esigenze in evoluzione della società.
Monitoraggio e valutazione
Per garantire il successo della proposta, è fondamentale un sistema di monitoraggio e valutazione continui. Dovrebbero essere stabiliti indicatori chiave di prestazione e parametri di riferimento per monitorare i progressi e apportare le modifiche necessarie.
L’importanza da parte della Pubblica Amministrazione di monitorare e valutare il fenomeno del femminicidio e della violenza domestica è fondamentale per affrontare efficacemente questo problema sociale che ha gravi ripercussioni sulla vita delle donne e sulla società nel suo complesso. Attraverso un monitoraggio accurato e una valutazione continua, è possibile identificare le tendenze, misurare l’efficacia delle politiche esistenti e sviluppare strategie più efficaci per prevenire e combattere la violenza di genere.
Il monitoraggio costante consente inoltre di avere una visione chiara della portata del problema. Questi fenomeni spesso sono sottostimati a causa di una sottostimato del numero delle denunce e della mancanza di dati affidabili. Il rilevamento accurato dei casi è essenziale per valutare l’entità del problema e fornire risorse adeguate ad affrontarlo.
Il monitoraggio a lungo termine permette di identificare tendenze e modelli nei casi di femminicidio e violenza domestica. Queste informazioni sono fondamentali per comprendere meglio le cause sottostanti e le situazioni a rischio, consentendo così di sviluppare interventi mirati.
Con dati accurati, la Pubblica Amministrazione può allocare in modo più efficiente le risorse disponibili. Ciò significa garantire che i servizi di supporto alle vittime siano adeguatamente finanziati e che siano disponibili i fondi necessari per programmi di prevenzione e sensibilizzazione.
La valutazione costante delle politiche e degli interventi è essenziale per misurarne l’efficacia. Ciò include esaminare se le leggi contro il femminicidio e la violenza domestica sono adeguate e se vengono applicate in modo efficace. Inoltre, è importante valutare l’efficacia dei servizi di supporto alle vittime e dei programmi di prevenzione.
I dati raccolti attraverso il monitoraggio e la valutazione forniscono una base solida per lo sviluppo di politiche basate su evidenze. Questo significa che le decisioni politiche possono essere prese in modo informato, utilizzando dati reali per affrontare il problema.
Il monitoraggio può aiutare a identificare le esigenze specifiche delle vittime, inclusi gruppi vulnerabili come le donne con disabilità, le donne LGBTQ+ e le donne di minoranza etnica. Queste informazioni consentono di personalizzare i servizi di supporto e di garantire che nessuna vittima venga trascurata.
La pubblicazione di dati relativi al femminicidio e alla violenza domestica promuove la trasparenza e la responsabilità nelle azioni della Pubblica Amministrazione. Questa trasparenza può contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica e a spingere le istituzioni a fare di più per combattere la violenza di genere.
Il monitoraggio e la valutazione consentono anche di identificare le migliori pratiche sia a livello nazionale che internazionale. Queste esperienze possono essere condivise tra le agenzie governative e le organizzazioni non profit per migliorare le strategie di intervento.
La raccolta sistematica di dati sul femminicidio e la violenza domestica può stimolare la ricerca accademica e istituzionale su questi argomenti. Questa ricerca contribuisce a comprendere meglio il fenomeno e a identificare soluzioni più efficaci.
Il monitoraggio e la valutazione consentono di adattare le politiche e gli interventi alle esigenze in evoluzione della società. Ad esempio, possono essere sviluppate nuove politiche per affrontare le sfide emergenti, come la violenza online o le nuove forme di coercizione.
Conclusione
In conclusione, porre fine al femminicidio e alla violenza domestica è un obiettivo complesso ma raggiungibile. Questa proposta offre un approccio articolato che comprende riforme legislative, miglioramenti delle forze dell’ordine, servizi di supporto, istruzione, raccolta dati, collaborazione internazionale e finanziamenti sostenibili. Lavorando insieme su queste iniziative, si può creare una società più sicura ed equa per tutti, libera dalla piaga del femminicidio e della violenza domestica.
Bibliografie ragionate
Bibliografie Internazionali
1. Dobash, R. E., & Dobash, R. P. (2015). Violence against Wives: A Case against the Patriarchy. Routledge. – Questo lavoro fondamentale esamina le radici patriarcali della violenza domestica, offrendo un’analisi critica delle dinamiche di potere di genere alla base della violenza contro le donne.
2. Council of Europe. (2011). Combating Violence against Women: Stocktaking Study on the Measures and Actions Taken in Council of Europe Member States. Council of Europe Publishing. – Questo studio completo fornisce una panoramica delle misure e delle azioni intraprese dagli Stati membri del Consiglio d’Europa per combattere la violenza contro le donne, compresi il femminicidio e la violenza domestica.
3. Walby, S. (2009). The Cost of Domestic Violence: Up-date 2009. Lancaster University. – Questo studio si concentra sui costi economici della violenza domestica in Europa, mettendo in luce l’onere finanziario sostenuto da individui, comunità e società nel suo insieme.
4. Stöckl, H., Devries, K., Rotstein, A., Abrahams, N., Campbell, J., Watts, C., & Moreno, C. G. (2013). The Global Prevalence of Intimate Partner Violence Against Women. Science, 340(6140), 1527-1528. – Questo studio presenta una prospettiva globale, includendo i paesi europei, sulla violenza domestica contro le donne fornendo tassi di prevalenza e mettendo in evidenza la grandezza del problema.
5. Walby, S., & Towers, J. (2018). Untangling the Concept of Coercive Control: Theoretical Implications for Research and Policy. Violence Against Women, 24(3), 247-259.– Concentrandosi sul concetto di controllo coercitivo, questo articolo discute le implicazioni teoriche per la comprensione della violenza domestica e la sua rilevanza per le politiche e le pratiche.
6. Carvalho, J., Nobre, N., & Pinto, N. (2014). Femicide in Portugal: An Assessment of the Phenomenon. European Journal of Crime, Criminal Law, and Criminal Justice, 22(1), 1-29.– Questo studio esamina il femminicidio in Portogallo, analizzandone caratteristiche, modelli e risposte legali, contribuendo alla comprensione del femminicidio nel contesto europeo.
7. Council of Europe. (2018). Femicide in Europe: Annual Report 2018. Council of Europe Publishing.– Questo rapporto fornisce una panoramica completa del femminicidio in Europa, analizzando i dati di vari paesi ed evidenziando tendenze, fattori di rischio e risposte politiche.
8. Lombardo, E., & Garcia-Moreno, C. (2015). Intimate Partner Femicide: A Review of Risk Factors and Preventive Measures. Violence and Gender, 2(1), 3-9.– Questa review esplora i fattori di rischio associati al femminicidio da parte del partner, sottolineando l’importanza delle strategie di prevenzione e intervento.
10. Garcia-Moreno, C., Jansen, H. A., Ellsberg, M., Heise, L., & Watts, C. H. (2006) Prevalence of intimate partner violence: findings from the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence. The Lancet, 368(9543), 1260-1269.– Questo studio presenta i risultati dello studio multicentrico dell’OMS sulla salute delle donne e la violenza domestica, fornendo tassi di prevalenza e mettendo in evidenza l’estensione globale della violenza del partner, compresi i paesi europei.
11. Kimmel, M. S. (2017). Men, Masculinities, and Gender Politics in Femicide: Some Reflections on Connections and Disconnections. Men and Masculinities, 20(1), 102-112. – Questo articolo esplora il ruolo della mascolinità e della politica di genere nel femminicidio, discutendo le connessioni tra norme sociali, disuguaglianza di genere e violenza contro le donne.
12. European Institute for Gender Equality (EIGE). (2020). Femicide in the European Union: Analysis of existing data and policy responses. Publications Office of the European Union. – Questo rapporto dell’EIGE analizza i dati esistenti e le risposte politiche relative al femminicidio nell’Unione Europea, fornendo spunti sulla prevalenza, le caratteristiche e il quadro politico riguardante il femminicidio in Europa.
13. Hagemann-White, C. (2007). Violence against women: The European experience. Routledge. – Questo libro offre una panoramica della violenza contro le donne in Europa, esplorando il suo contesto storico, culturale e sociale, e discutendo varie forme di violenza, compresa la violenza domestica e il femminicidio.
14. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). Global Study on Homicide 2019: Gender-related Killing of Women and Girls. United Nations Publications. – Questo studio globale esamina gli omicidi di donne e ragazze legati al genere, compreso il femminicidio, fornendo dati, tendenze e analisi del problema in Europa e in altre regioni.
15. Myhill, A., & Hohl, K. (2017). Analysing the Police Role in Domestic Violence Cases: Can ‘Nudge’ Improve Policy and Practice? British Journal of Criminology, 57(1), 120-141. – Questo articolo si concentra sulla risposta della polizia ai casi di violenza domestica, esplorando il ruolo delle forze dell’ordine nel contrasto alla violenza domestica e discutendo le strategie per migliorarne politiche e pratiche.
16. European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). (2014). Violence against women: an EU-wide survey. Publications Office of the European Union. – Questo sondaggio condotto dalla FRA fornisce dati completi sulla violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, negli stati membri dell’Unione Europea, mettendo in luce la prevalenza, le conseguenze e i tassi di denuncia.
17. Kaya, F., & Kaya, B. (2014). Domestic Violence against Women in Turkey and European Union: A Comparative Study. European Scientific Journal, ESJ, 10(15). – Questo studio comparativo esamina la violenza domestica contro le donne in Turchia e nell’Unione Europea, evidenziando somiglianze, differenze e approcci politici per affrontare il problema.
18. Stöckl, H., Devries, K., Rotstein, A., Abrahams, N., Campbell, J., Watts, C., & Moreno, C. G. (2013). The global prevalence of intimate partner violence against women: A systematic review and meta-analysis. The Lancet, 382(9895), 859-865. – Questa meta-analisi fornisce una prospettiva globale sulla prevalenza della violenza del partner contro le donne, includendo i paesi europei. Offre una panoramica completa del problema, sintetizzando i dati di vari studi per stimare i tassi di prevalenza globali.
Bibliografie Europee
1. “Femicide: A Global Issue that Demands Action” Shalva Weil and Consuelo Corradi – Questo libro fornisce una prospettiva globale sul femminicidio, esplorando le sue radici storiche e il suo trattamento nei vari paesi, compresa l’Europa.
2. “Violence Against Women in Europe” edited by Sylvia Walby, Johanna Neary, and Anke Strüver – Questo lavoro completo offre una panoramica della violenza contro le donne in Europa e delle misure adottate per combatterla.
3. European Institute for Gender Equality (EIGE): https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/european-institute-gender-equality-eige_it – Il sito web dell’EIGE offre una vasta gamma di pubblicazioni, rapporti e bibliografie relative alla violenza di genere in Europa.
4. Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) – Questo importante quadro giuridico svolge un ruolo fondamentale nel contrastare la violenza di genere in Europa ed è utilizzato come riferimento critico per comprendere le misure politiche e le direttive.
5. “European Journal of Women’s Studies” – Questa rivista accademica pubblica articoli e studi su vari aspetti delle donne e del genere in Europa, compresa la ricerca sulla violenza contro le donne.
6. “Understanding Femicide: A Global Comparative Analysis“ edited by Robert M. Peck – Questa opera offre un’analisi comparativa del femminicidio in diverse regioni, compresa l’Europa.
7. “Domestic Violence and Mental Health: A Cross-sectional Survey of Women Seeking Help from Domestic Violence Support Services” – Uno studio che esplora l’intersezione tra violenza domestica e salute mentale tra le donne in Europa
8. “Engaging Men and Boys in Preventing Violence Against Women: Applying a Cognitive Behavioral Approach” – Uno studio che si concentra sul coinvolgimento degli uomini e dei ragazzi nella prevenzione della violenza di genere in Europa.
9. “Economic Costs of Violence Against Women in the European Union” – Un rapporto che evidenzia le implicazioni economiche della violenza contro le donne nell’UE.
10. “Intimate Partner Violence and Domestic Violence in Europe: A Comprehensive Review of National and International Data” – Questa ricerca fornisce spunti sulla prevalenza e sulle risposte alla violenza domestica nei paesi europei.
11. “Prevalence and Factors Associated with Intimate Partner Violence in Europe: A Systematic Review” – Una review sistematica completa sulla prevalenza e sui fattori associati alla violenza del partner nei paesi europei.
12. “Legal Responses to Domestic Violence in Europe: A Comparative Analysis” – Un’analisi approfondita delle risposte legali alla violenza domestica in diversi paesi europei, mettendo in luce le variazioni nelle politiche e la loro efficacia.
13.”Addressing Gender-based Violence in Europe: A Policy Perspective” – Un’opera incentrata sulla politica che esamina gli approcci e le iniziative adottate dai paesi europei per affrontare la violenza di genere.
14. “Silent Voices: Exploring the Experiences of Immigrant Women Facing Domestic Violence in Europe”- Uno studio che si addentra nelle sfide affrontate dalle donne immigrate che subiscono violenza domestica in Europa.
15. “Impact of Domestic Violence on Children: A European Perspective” – Uno studio che esplora l’impatto della violenza domestica sui bambini in Europa e gli interventi in atto per proteggerli.
16. “Violence Against Women and Girls: A European Human Rights Issue” – Un rapporto che discute la violenza contro le donne e le ragazze in Europa attraverso il rispetto dei diritti umani, sottolineando la necessità di protezioni legali e responsabilità.
17. “Evolving Challenges: Technology-Facilitated Abuse and Gender-based Violence in the Digital Age” – Un’analisi delle problematiche sempre più emergenti nel contesto della violenza di genere in Europa., tra cui gli abusi facilitati dalla tecnologia e le molestie online.
18. “The Intersection of Economic Empowerment and Domestic Violence: A Case Study of European Initiatives” – Un esame delle iniziative e dei programmi volti a potenziare economicamente le donne come mezzo per combattere la violenza domestica in Europa.
19. “Intersectionality in Understanding and Addressing Violence Against Women in Europe” – Un esame delle iniziative e dei programmi volti a potenziare economicamente le donne come mezzo per combattere la violenza domestica in Europa.
20. “Access to Support Services for Victims of Violence: A Comparative Analysis of European Countries” – Un’analisi della facilità d’accesso ai servizi di sostegno per le vittime della violenza in diversi paesi europei, mettendo in luce le lacune e i miglioramenti necessari nella fornitura dei servizi.
Ti è stato utile questo articolo?
ISCRIVITI alla nostra

×
Iscriviti alla nostra Newsletter
Rimani aggiornata con i nuovi corsi e le promozioni.

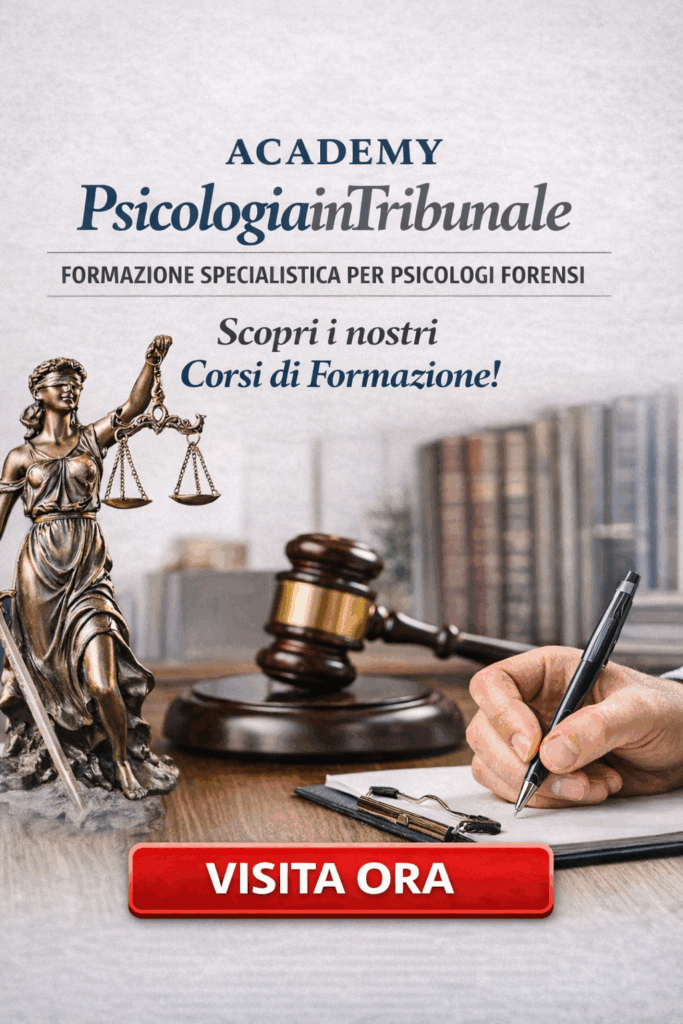
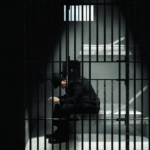






Comment (1)
Domenico Ianuale
L’articolo riguardante la violenza sulle donne e la’aplicazione delle relative misure di precauzione conseguenti all’accertamento e alla punizione di tale reato come misure coeritive e l’allolntanamento
dalla sede di residenza della persona offesa, ai sensi dell’art. 380 C.P.P. ma e’ compito dei servizi sociali
rieducare e prevenire tali condotte devianti e comportamenti antisociali , che sono il campanello d’allare
che puo’ rivelare un disagio psichico che puo’ provocare un reato penale, si e’ rivelato molto interessante
per la materia trattata che e’ di attualita’ , ma noi come societa’ avremmo il compito di rieducare e prevenire tali comportamenti,con interventi di un equipe sociopsicopedagogica dei Servizi sociali di medicina territoriale .