La responsabilità genitoriale tra etica della cura, etica del diritto ed etica della valutazione

La responsabilità genitoriale tra etica della cura, etica del diritto ed etica della valutazione
Paola Maria Oliviero
corsista del corso di alta formazione Ruolo e Funzioni del Consulente Tecnico Psicologo in Ambito Minorile
Il tema della responsabilità genitoriale richiama in sé diverse riflessioni inerenti questioni etiche che riguardano tanto i genitori e i figli (nelle loro funzioni di espletamento di cura e di diritto a riceverne e donarne), quanto coloro che sono chiamati a valutarne la validità e l’efficacia nell’esercizio più o meno funzionale delle relative competenze.
Il filosofo tedesco Jonas Hans (1979) fornisce una definizione ben chiara del concetto di “responsabilità”, come una protensione verso il futuro, connotato di cure mirate al benessere, all’educazione e all’emancipazione dell’individuo. In quest’ottica il paradigma dell’azione responsabile si estrinseca in vista degli effetti futuri prevedibili di una data condotta e nelle capacità responsive ai bisogni essenziali propri e altrui.
A partire da queste considerazioni filosofiche, il neuropsichiatra infantile prof. Stefano Benzoni (2015) delinea le caratteristiche della crisi dell’etica (e quindi dell’annesso concetto di responsabilità) nell’epoca contemporanea, così come essa si manifesta in particolare anche nell’ambito delle funzioni, delle competenze e delle responsabilità genitoriali, sia materne che paterne. L’autore sottolinea a tal proposito quanto sia stato determinante il passaggio dall’“etica della moderazione e della limitazione” all’etica contemporanea delle “possibilità illimitate e dell’intrattenimento a tutti i costi”. Siamo ormai trainati da una Società che ci chiede continuamente di “divertirci”, di “godere”, “di “essere noi stessi” di “realizzarci” e soddisfare tutti i nostri desideri, con l’imposizione di un “mandato del godimento” modulato in ogni sua manifestazione da un sistema sociale che ne stabilisce le regole consumistiche, finalizzate alla creazione continua ed illusoriamente inarrestabile di nuovi bisogni da dover soddisfare, rendendoci sempre più fragili, insoddisfatti, confusi e dipendenti.
Questi mutamenti socioculturali hanno avuto e continuano ad avere un impatto fortemente condizionante sui nostri assetti ideologici e, di conseguenza, sul nostro approccio alla vita e all’educazione, rischiando di portarci (quando non ben centrati e consapevoli) a ribaltare anche i più basilari canoni del buon senso e della pedagogia elementare:
“In fondo noi ci troviamo in un tempo in cui si chiede ai propri figli di dire la loro circa decisioni difficili e ci si sostituisce ai figli nel prendere decisioni semplici: gli si allacciano le scarpe e gli si porta la cartella e poi si chiede ad un bambino di 3 anni se vuole una sorellina e che nome darle”.
Lanza, 2020
Questa realtà lambisce tutti i settori sociali, comprese le professionalità che si occupano della cura e della tutela dell’infanzia nei vari ambiti: scuole, servizi sociali, consultori familiari, case famiglia e associazioni. Lo scandalo della scuola materna “Olga Rovere” di Rignano Flaminio (RM) nel 2006 e il caso del “Centro Studi Hansel e Gretel” di Bibbiano (RE), portato alle cronache nel 2018, rappresentano due esempi lampanti della crisi etica che riguarda in dettaglio sia la valutazione della genitorialità da parte di professionisti che antepongono i propri interessi economici alla tutela del minore, sia la selezione del corpo docente responsabile dell’educazione scolastica, sia la divulgazione mediatica che pare mirare più al “sensazionalismo” fine a se stesso che all’informazione “educativa”.
Questo di seguito è un tipico quesito posto dal Magistrato al Consulente Tecnico d’Ufficio da lui nominato in un procedimento di separazione giudiziale per la valutazione delle competenze genitoriali finalizzata alla scelta del miglior regime di affidamento per il minore:
“Dica il CTU quali siano le condizioni psichiche dei genitori e le loro capacità genitoriali, con particolare riguardo alla capacità di cura, di protezione, di educazione, di lettura dei comportamenti del minore in termini di stati mentali, della funzione empatica, affettiva ed organizzativa, e alla capacità di garantire l’accesso del minore all’altro genitore, salvaguardandone la funzione agli occhi del figlio e condividendone attivamente la responsabilità”.
Appare evidente il riferimento alle funzioni genitoriali proposte da Visentin (2006), che rimandano in ogni caso ad una nozione di genitorialità considerata come una serie organica di azioni, comportamenti, attitudini e disposizioni che per loro natura risultano essere inevitabilmente contingenti e contestualizzati all’interno di una specifica storia familiare inserita, a sua volta, in uno specifico contesto socio-culturale. Questa contestualizzazione risulta essere il primo punto critico della questione etica, rendendo la funzione della cura un concetto relativo, non assolutistico, quindi facilmente reinterpretabile e rinviabile all’idea popolare che “ogni genitore sia bravo a casa sua”.
Di conseguenza, lo stesso problema epistemologico del rischio di “inflazione diagnostica” in campo psicologico e psichiatrico delineato da Allen Frances (2013) si riscontra inevitabilmente anche nelle definizioni scientificamente riconosciute riguardo le competenze genitoriali poiché anche queste ultime risentono del loro intrinseco carattere relativistico.
Secondo Benzoni (2021) l’unica possibilità affinché possa essere condotta un’indagine quanto più attendibile e valida possibile in questo campo risulta dunque essere l’abbandono di un approccio rigidamente dicotomico a favore di una flessibilità valutativa che tenga conto della qualità progressiva (non cristallizzata) di ogni singola competenza genitoriale che si va ad osservare e valutare, così come emerge all’interno di quel determinato contesto familiare, in quel determinato momento storico, in una specifica relazione di cura.
Partendo da tali considerazioni, Benzoni cita Vergani (2015) nel porre l’etica della cura (contingente e mutevole a seconda dei tempi e dei contesti) in stretta relazione all’etica del diritto (che invece ha un valore universale ed assoluto), rintracciando nel concetto e nell’esercizio stesso della “responsabilità” l’unica possibile soluzione al dilemma della loro integrazione.
“Responsabilità” intesa come legame tra le due dimensioni etiche (della cura e del diritto), come “pre-occupazione” finalizzata al “Bene” e basata su princìpi morali riferiti a valori sia individuali che collettivi, così come viene intesa nell’ art. 316 comma 1 del Codice civile:
“Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio (…)”
e nell’art. 18 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza:
“…entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo, (…) guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo”.
Tale “responsabilità”, d’altra parte, nella sua accezione di “pre-occupazione” verso i bisogni attuali e futuri dell’altro (nella fattispecie del minore) non può che riguardare tanto i genitori e i tutori quanto i loro valutatori.
Ma a questo punto verrebbe da chiedersi come tutte queste figure coinvolte, nessuna esclusa, possano riconoscere in modo quanto più corretto possibile i bisogni altrui e le più adeguate modalità di soddisfacimento degli stessi se non attraverso una formazione continua sui costrutti scientifici che ne permettano la conoscenza e tramite un esercizio costante di consapevolezza, monitoraggio, confronto ed elaborazione dei propri stati emotivi e mentali e delle proprie dinamiche relazionali, per evitare di incorrere tanto in errori educativi quanto in errori di valutazione. Di conseguenza sarebbe auspicabile una formazione teorica e pratica inerente l’acquisizione delle competenze genitoriali, non solo (come già ovviamente previsto) da parte di chi è chiamato a valutarle, ma anche di tutti coloro che potenzialmente potranno diventare genitori, poiché, come sostiene Massimo Recalcati (2021), l’atto procreativo naturale non assicura in sé la presenza o l’acquisizione delle competenze di cura necessarie ad un corretto sviluppo psicofisico del nascituro, ma, così come per le procedure di valutazione per genitori adottivi, anche “la nascita naturale necessiterebbe di un’adozione (seppur) simbolica” (Zoja, 2016), che preveda una piena consapevolezza ed assunzione di responsabilità riguardo tale necessità, nel superiore interesse del “nascituro” non solo del minore.
Hans Jonas (2009) pone l’accento sulla sostanziale differenza tra il “diritto” e il “dovere” di un genitore nei confronti delle necessità di cura che porta in sé il neonato per il solo fatto di esistere, necessità di cura che un genitore ha sempre il potere (“diritto”) di soddisfare, ma non sempre la volontà o la capacità di farlo (“dovere”, che nel caso vada contro le proprie volontà o/e capacità, può molto facilmente produrre enormi danni alla salute psicofisica del neonato stesso). È infatti ormai conclamato, e supportato da innumerevoli studi e ricerche nel campo della neuropsicologia infantile e dell’età evolutiva (Gallese, 2007), il fatto che lo sviluppo neuropsicologico globale dell’individuo, sin dalla vita intrauterina, sia fortemente influenzato dalla personalità, dalle competenze di accudimento e dagli stili di attaccamento propri dei genitori e delle figure primarie di accudimento.
E questo, a mio avviso, sarebbe un vulnus preventivamente evitabile attraverso un’educazione scolastica al riconoscimento e alla gestione delle emozioni e dei conflitti sin dalla più tenera età e tramite una valutazione preventiva ed un continuo monitoraggio delle competenze di cura dei futuri genitori, come previsto nei casi di adozione.
Appare molto interessante la riflessione che Vergani (2015) propone riguardo il concetto di uguaglianza su cui si fonda il Diritto in relazione alla responsabilità genitoriale, nel cui ambito tale fondamento viene ovviamente a mancare, data l’intrinseca disparità di autodeterminazione e di potere decisionale esistente sia tra l’adulto e il bambino che tra il genitore e il suo valutatore. Il legame morale tra le persone, secondo l’autore, troverebbe il suo fondamento proprio in questa disuguaglianza che, per sua natura, imporrebbe l’acquisizione di responsabilità sia nella cura da parte dell’adulto nei confronti del bambino che nella valutazione da parte del professionista nei confronti del genitore.
D’altro canto, sottolinea Benzoni (2021), l’azione responsabile presuppone in sé una decisione ed una volontà del soggetto atte a soddisfare in modo adeguato i bisogni propri e altrui, ed una capacità di proiettare nel futuro l’esito di tale azione. Ma, secondo l’autore, non bastano le buone intenzioni a rendere un’azione “responsabile”, piuttosto risulta necessaria una struttura identitaria, al contempo sufficientemente stabile e flessibile, con un buon senso di continuità del sé, tale da permettere l’ideazione e la realizzazione di un’azione di cura proiettata nel futuro.
L’estrema complessità di tale indagine, continua l’autore, non può trovare soluzione unicamente nelle procedure, nelle tecniche e nelle definizioni nosografiche (che indiscutibilmente rappresentano un’imprescindibile bussola e forniscono gli strumenti atti ad indagare ed agire con cognizione di causa), ma può essere efficacemente approcciata solo con un perseverante impegno verso il mantenimento di alte soglie di consapevolezza sia nel focalizzare lo specifico contesto in cui si opera, sia nel finalizzare qualunque intervento valutativo e/o decisionale al Bene superiore della parte (soggetto di diritto) più fragile (il bambino), senza mai perdere di vista che tale “Bene” è sempre orientato all’acquisizione dell’autonomia e dell’emancipazione emotiva ed esistenziale del bambino che da “oggetto di cura” si auspica far diventare “soggetto di responsabilità” (Freire, 1996).
Ogni legame di cura è dunque funzionale e responsabile solo se teso al suo scioglimento:
“I vostri figli non sono figli vostri.
Kahlil Gibran, 1923
Sono i figli e le figlie del desiderio che la vita ha di se stessa.
Essi non provengono da voi, ma attraverso di voi.
E sebbene stiano con voi, non vi appartengono.
Potete dar loro tutto il vostro amore, ma non i vostri pensieri.
Perché essi hanno i propri pensieri.
Potete offrire dimora ai loro corpi, ma non alle loro anime.
Perché le loro anime abitano la casa del domani, che voi non potete visitare, neppure nei vostri sogni.
Potete sforzarvi di essere simili a loro, ma non cercare di renderli simili a voi.
Perché la vita non torna indietro e non si ferma a ieri.
Voi siete gli archi dai quali i vostri figli, come frecce viventi, sono scoccati (…).”
Sempre Benzoni (2021) pone poi l’accento sulla distinzione tra la visione giurisprudenziale e quella psicologica del concetto di responsabilità, sottolineando come nel primo caso essa valuti la natura dell’azione compiuta (assunzione di responsabilità) o meno (omissione di responsabilità), mentre la Psicologia si concentra sulla struttura e sulle funzioni di personalità caratteristiche del soggetto che compie quella determinata azione in quel determinato contesto relazionale in un determinato momento.
A partire da questa considerazione, lo stesso Benzoni (idem) elenca infine le caratteristiche di una valutazione etica e responsabile delle competenze genitoriali da parte degli esperti che, oltre ad impegnarsi in una formazione ed un aggiornamento continui sulla materia in esame e a rispettare le specifiche linee guida del settore dovranno, a suo avviso, esercitare ed incrementare le seguenti attitudini personali:
- capacità di porsi delle domande;
- sensibilità ad analizzare la natura delle domande che ci si pone e che ci vengono poste;
- capacità di cogliere, osservare e gestire la “complessità” delle dinamiche intrapsichiche ed interazionali;
- capacità di riconoscere il nostro punto di vista e i nostri vissuti in relazione all’altro (Sclavi, 2003);
- consapevolezza del carattere “probabilistico-prognostico” della richiesta valutativa;
- consapevolezza delle omissioni e dei sottintesi che si attuano nelle valutazioni;
- consapevolezza del contesto in cui si valuta;
- consapevolezza delle dinamiche relazionali in atto durante il processo valutativo e dell’influenza dell’osservatore sull’osservato;
- consapevolezza dei propri pregiudizi e delle proprie categorizzazioni (Formenti, 2012);
- consapevolezza dei propri limiti conoscitivi;
- predisposizione al confronto continuo con i colleghi;
- capacità di porre l’altro al centro e di marginalizzare i nostri vissuti;
- capacità di integrare ed adattare le competenze tecniche in una visione d’insieme;
- curiosità ed atteggiamento falsificazionista (Popper, 1969).
Riferimenti bibliografici
Benzoni S. (2015), L’infanzia non è un gioco. Paradossi e ipocrisie dei genitori di oggi, Laterza, Roma.
Benzoni S. (2021), Il mestiere impossibile. La genitorialità e la sua valutazione, Istituto Milanese di psicologia Giuridica. Formenti L. (2012), Re-inventare la famiglia, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN).
Frances A. (2013), Primo, non curare chi è normale. Contro l’invenzione delle malattie, Boringhieri, Torino.
Freire P. (1996), Pedagogia dell’Autonomia. Saperi necessari per la pratica educativa, Gruppo Abele, Torino, 2014. Gallese V. (2007), “Dai neuroni specchio alla consonanza intenzionale. Meccanismi neurofisiologici dell’intersoggettività, in Rivista di Psicoanalisi, vol LIII, 1, pp. 197-208.
Gibran K. (1923), Il Profeta, Knopf, New York.
Jonas H. (1979), Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 2009.
Lanza S. (2020), Perdere tempo per educare. Educare all’utopia nell’epoca del digitale, WriteUp Site, Roma.
Popper KR. (1969), Scienza e filosofia. Problemi e scopi della scienza, Einaudi, Torino, 2000.
Recalcati M. (2013), Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre, Feltrinelli, Milano.
Recalcati M. (2021), Il mestiere impossibile. La genitorialità e la sua valutazione.
Sclavi M. (2003), Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte, Mondadori, Milano.
Vergani M. (2015), Responsabilità. Rispondere di sé, rispondere dell’altro, Cortina, Milano.
Visentini G.L. (2006), Le Funzioni della genitorialità, in Associazione Genitorialità aps.
Zoja L. (2016), Il gesto di Ettore, Boringhieri, Torino.

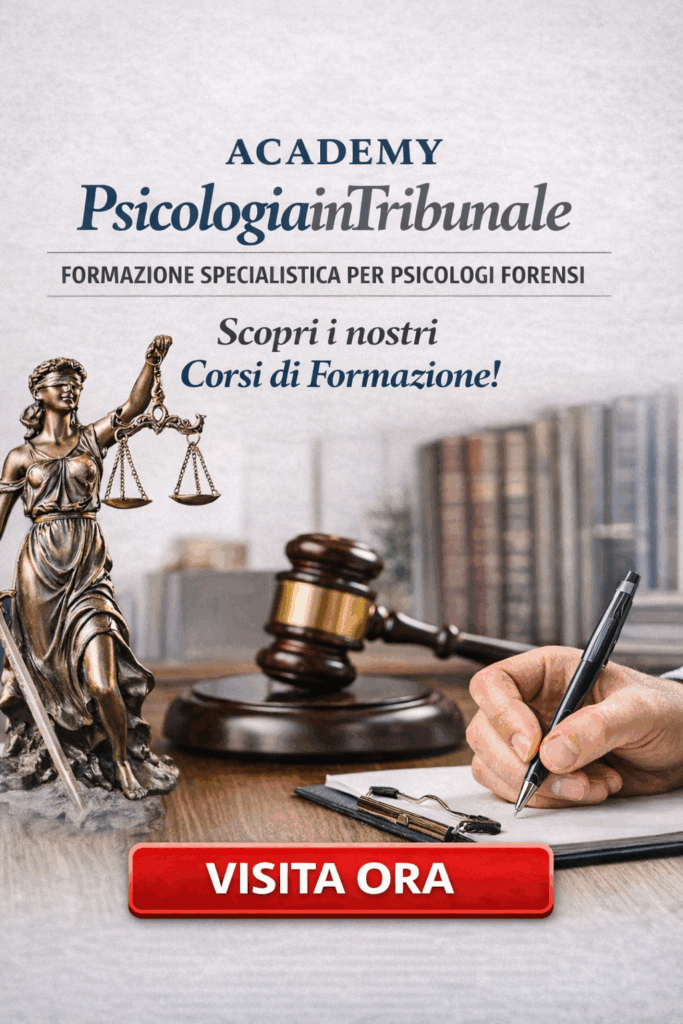
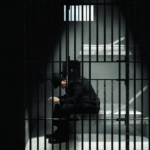






Comments (4)
Graziella
Bellissima l’immagine del processo di autonomia del bambino che da “oggetto di cura” ci si auspica diventi “soggetto di responsabilità”.
Complimenti Paola, tutti noi genitori dovremmo aver chiaro questa tappa evolutiva “obbligata “ dei nostri figli che stanno con noi ma non ci appartengono!
Paola Maria Oliviero
Grazie Graziella,
quello del genitore credo davvero sia il mestiere più difficile del mondo ma anche il meno tutelato e meno “riconosciuto” socialmente purtroppo 🙁
Paola Ascenzi
Bellissimo articolo…e come si dice sempre…quanto è difficile essere genitore…sotto tanti punti di vista! Complimenti Paola e grazie
Paola
Bellissimo articolo…e come si dice sempre…quanto è difficile.essere genitori…sotto tanti punti di vista! Complimenti Paola e grazie