Ultimi Commenti
Ho avuto il piacere di partecipare ai corsi di formazione dedicati alla psicologia in tribunale e devo dire che sono…
Non comprendo come la si metta con la costituzione. Secondo il principio che la legge deve essere uguale per tutti…
Un argomento molto attuale trattato a 360° da oratori competenti e capaci di coinvolgere. Aspetti teorici ma anche soluzioni pratiche.…
Percorso valido per avere uno sguardo ampio sull'argomento proponendo spunti operativi utili
Ascoltare è esserci
21/10/2023 2023-10-21 1:46Ascoltare è esserci
Laura Monteleone
Psicologa Giuridica e Forense, Psicoterapeuta, professionista della Rete di Psicologia in Tribunale.
La nostra è l’epoca della iper connessione, dove prevale la comunicazione tramite immagini o con una condivisione di contenuti ‘slogan’ che hanno l’effetto di svuotare spesso il contenuto stesso di ciò che viene detto. In particolare i giovani, bambini e adolescenti, hanno ormai assimilato questo modo di comunicare con gli altri, con il mondo esterno, fruendo dell’immediato piacere del gusto di entrare nelle vite degli altri subito e con l’illusione di essere ascoltati.
In realtà, questo modo di comunicare manca nella sua dinamica di alcuni elementi che de-privano la sua funzione, in cui c’è un emissione del messaggio e un agente che riceve-recepisce il contenuto di ciò che è stato trasmesso, ovvero ascolta.
Non basta ascoltare ma ‘saper ascoltare’, e questa è un’abilità, un talento che bisogna saper coltivare e formare. Per Plutarco il
“saper ascoltare è fondamentale per poter arrivare a quella conoscenza di sé e degli altri, perché la mente ha bisogno di una scintilla che l’accenda e vi infonda l’impulso della ricerca e un amore ardente per la conoscenza e la verità”.
Attraverso la narrazione di sé e la risposta che riceve dall’altro, l’essere umano aumenta la consapevolezza di se stesso, delle proprie potenzialità e si proietta verso i propri obiettivi, e questo si costruisce ancora di più se chi è ascoltato è un minore.
Secondo l’articolo 12 della convenzione ONU sui diritti dei minori:
“Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”.
Bambini e adolescenti, sempre secondo la Convenzione ONU, hanno diritto alla libertà di espressione e all’essere ascoltati non solo nei procedimenti giudiziari e amministrativi, ma anche nella sfera privata, nei rapporti con i familiari e in quelli sociali.
L’ascolto così si trasforma in ascolto attivo, dove l’approccio alla comunicazione è di tipo partecipativo, orientato alla valorizzazione dello scambio interattivo tra i soggetti coinvolti, attento alla componente emotiva e finalizzato all’attivazione delle risorse dei singoli e della collettività per affrontare situazioni problematiche e a rischio. Ascoltare attivamente coinvolge la sfera empatica di chi ascolta, significa mettersi nei panni dell’altro, riconoscendo e accettando il suo punto di vista, e cercando di comprendere le emozioni, i dubbi e le preoccupazioni che manifesta.
L’ascolto presuppone anche la restituzione all’altro di quanto è stato compreso, dimostrando in tal modo la nostra presenza nella relazione, il rispetto e il riconoscimento che nutriamo per lui.
Spesso capita nel lavoro di psicologo oltre che nell’attività psicoterapeutica di accogliere la richiesta di aiuto di minori, sia in ambito scolastico, tramite sportelli di ascolto, sia in contesti istituzionali come comunità o istituti penali per minorenni. Ciò comporta per un minore, bambino e adolescente, la possibilità di sentirsi ascoltato – senza sentirsi giudicato. Essere lì, al suo fianco, apre la strada ad un riconoscimento di sé, alla possibilità per il minore di sentire di esistere. Una volta un ragazzo, in carcere, mi disse: “Sa, la possibilità di sapere che lei mi ascolta, mi fa sentire che esisto”.
Nella misura in cui sappiamo ascoltare, facciamo sentire all’altro di esserci, di essere insieme. Non basta sentire o essere fisicamente presenti, è necessaria la nostra presenza emotiva. Per un bambino o per un adolescente essere ascoltati significa prima di tutto essere visti, riconosciuti, compresi.
La vita frenetica che riempie la nostra quotidianità mette distanze. Raramente ci rendiamo conto di avere una connessione fittizia e apparente con l’altro, e ciò contrasta con quel naturale bisogno di essere invece in sintonia con gli altri. Per cui i genitori sono in sintonia con i figli, gli insegnanti con gli alunni, gli amici tra di loro o piuttosto sono inconsapevoli di essere in relazioni dove la connessione si trasforma in continue sollecitazioni all’apparire e alla competizione? Mettersi in ascolto, soprattutto con un minore, richiede tempo ed impegno per l’adulto, per poter osservare, guardare, parlare, ascoltare, essere presenti.
La pandemia e il suo post hanno messo in luce la necessità dei giovanissimi di essere ascoltati. Oggi, la richiesta di aiuto da parte di questi ultimi si è moltiplicata in maniera impressionante ed è quindi un chiaro indicatore di quanto il periodo pandemico abbia contagiato la loro sfera psicologica. Il cambiamento delle abitudini, delle dinamiche relazionali, dello stile di vita e della comunicazione ha rappresentato un modo nuovo di stare con se stessi e con l’altro a cui soprattutto gli adolescenti si sono trovati impreparati ed inadatti.
Inoltre, le limitazioni sperimentate durante il periodo di isolamento, avendo messo nella condizione di stare più in contatto con se stessi, ha condotto molti a percepire un vuoto fatto di noia, di incapacità di comunicare e di esprimere le proprie emozioni, amplificando le condizioni di malessere emotivo e relazionale.
Secondo L’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le conseguenze della pandemia sulla salute pubblica sono senza precedenti, la salute mentale e il benessere di intere società sono state gravemente colpite da questa nuova crisi e richiedono attenzioni che non è possibile trascurare.
Le regole sociali imposte durante il periodo del lockdown sono in aperto contrasto, ad esempio, con la naturale tendenza degli adolescenti ad esplorare, a ricercare autonomia e nuove esperienze, a costruire relazioni significative al di fuori della famiglia di origine e a sperimentare una nuova consapevolezza della propria identità corporea (Scabini e Iafrate, 2019).
Il cambiamento delle proprie abitudini e delle routine ha privato i giovani non solo degli spazi educativi e scolastici, ma anche di quelli sportivi e ricreativi. Il disorientamento che ne è conseguito è stato spesso sottovalutato o negato.
Allo scopo di mettere in atto interventi efficaci, è necessario costruire un’alleanza con l’adolescente, ascoltandolo empaticamente, cercando di comprendere il suo punto di vista, i suoi valori, i suoi schemi di riferimento, le sue domande, mettendo in discussione il nostro modo preconcetto di valutare le situazioni.
Allearsi presuppone il nostro essere autentici, restando aperti a ciò di cui l’adolescente ha bisogno. Significa aiutarlo a comprendere i suoi problemi, le sue aspirazioni, i suoi bisogni, rimanendo al suo fianco anche in situazioni particolarmente complesse, senza giudicarlo.
Quando interagiamo con bambini e adolescenti spesso mettiamo in atto dinamiche di svalutazione che generano in loro reazioni negative di allontanamento e chiusura, che influiscono negativamente sulla relazione ma anche sul loro sviluppo emotivo. Nei casi di abuso o maltrattamenti, l’ascolto del minore dovrebbe essere invece focalizzato sui loro vissuti e sulle loro esperienze, sulla complessità dolorosa delle situazioni in cui sono costretti a crescere (L. Cancrini, La cura delle infanzie infelici).
Ascoltare non è sentire, va oltre, è di più. Non è basarsi solo sull’udire, ma sulla necessità di attivare tutta la nostra capacità sensoriale, che consente di conoscere l’altro attraverso la curiosità, l’attenzione, la concentrazione, l’empatia e la perseveranza.
Ricordiamo: ascoltare è esserci!

Laura Monteleone
Psicologa giuridica, psicoterapeuta, CTU c/o il Tribunale di Catania, docente di Psicologia Giuridica e della Devianza c/o la Scuola di Formazione e Aggiornamento dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza di Catania. Già consulente c/o l’Istituto Penale per i Minorenni Bicocca di Catania, professionista della Rete di Psicologia in Tribunale.
Dal nostro Blog

2,3 miliardi di bambini e adolescenti: il futuro dell’umanità chiede ascolto

Transgender Day of Remembrance: tra consapevolezza collettiva e tutela dei diritti

Vittime della strada: prevenzione e trauma. Il ruolo centrale della psicologia
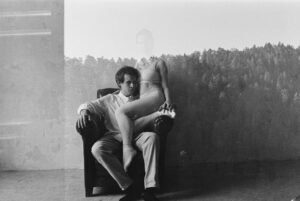
Esplorazione clinica della folie à deux

La violenza non è solo fisica ma anche e soprattutto psicologica

Figlicidio paterno: cause, fattori psicopatologici e dinamiche familiari
Dalla nostra Academy

Parliamo di Psicologia Giuridica con… Maria Naccari Carlizzi, Renata Rizzitelli e Daniela Ajovalasit | Martedì 9 Dicembre 2025 – ore 18:30 – 20:00
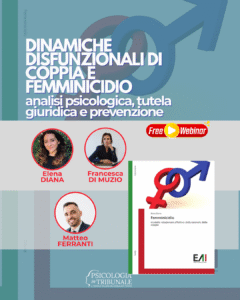
Dinamiche disfunzionali di coppia e femminicidio: analisi psicologica, tutela giuridica e prevenzione

Affetti da custodire. Diritti, infanzia e resilienza nelle separazioni
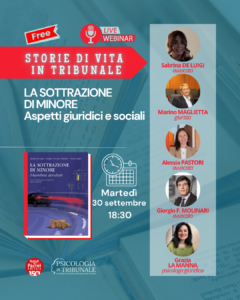
La sottrazione di minore. Aspetti giuridici e sociali | Martedì 30 Settembre 2025 – ore 18:30

Parliamo di Psicologia Giuridica con… Aurea Dissegna, Marco Imperato e Daniela Ajovalasit | Giovedì 25 Settembre 2025 – ore 18:30






Webinar utilissimo, molto formativo, svolto da importanti personalità. Sono onorato di aver partecipato.