Ultimi Commenti
Ho avuto il piacere di partecipare ai corsi di formazione dedicati alla psicologia in tribunale e devo dire che sono…
Non comprendo come la si metta con la costituzione. Secondo il principio che la legge deve essere uguale per tutti…
Un argomento molto attuale trattato a 360° da oratori competenti e capaci di coinvolgere. Aspetti teorici ma anche soluzioni pratiche.…
Percorso valido per avere uno sguardo ampio sull'argomento proponendo spunti operativi utili
Adolescenza e smartphone: un divieto per promuovere il benessere
31/10/2024 2024-11-04 17:02Adolescenza e smartphone: un divieto per promuovere il benessere

Adolescenza e smartphone: un divieto per promuovere il benessere
Alessia Mensurati, psicologa ed esperta di Neuropsicologia clinica e riabilitativa, con background in Neuroscienze Cliniche. Appassionata di Psicologia Giuridica e Neuropsicologia Forense, collabora con la redazione di Psicologia in Tribunale.
La proposta presentata da Daniele Novara e da Alberto Pellai, rispettivamente pedagogista e medico psicoterapeuta, ha catalizzato l’attenzione di un pubblico sicuramente eterogeneo. Basta guardare i grandi nomi di professionisti della Salute, così come del mondo dello spettacolo che spiccano tra i firmatari di quella che – inizialmente – era stata lanciata come petizione su Change.org “Stop smartphone e social sotto i 16 e 14 anni: ogni tecnologia ha il suo giusto tempo”.
Ma di cosa tratta nello specifico?
Ebbene, la richiesta è quella di porre un divieto di utilizzo degli smartphone a chi ha un’età inferiore a quella di 16 e 14 anni. Le motivazioni principali che si possono leggere sulla pagina della petizione sono: ridurre l’incidenza della dipendenza da cellulari e promuovere le esperienze nella vita reale per soggetti che sono, in tutto e per tutto, ancora in fase di sviluppo psico-fisico.
A partire da queste due motivazioni trainanti, ci sarà tra i lettori chi avrà già avuto modo di intuire che gli aspetti retrostanti sono nettamente più articolati e sfaccettati. Qui di seguito, li andremo ad esporre in maniera più estesa tenendo conto del fatto che tutti gli elementi che emergeranno non sono a compartimenti stagni, ma sono in costante interazione tra loro, influenzandosi vicendevolmente.
Aspetti biologici che andremo ulteriormente a dividere in neurologici e fisiologici
In merito all’espansione e specializzazione neuronale ci sono oramai consolidate evidenze empiriche relative al concetto di maturità mentale e di sviluppo dei lobi frontali, la cui maturazione non termina prima dei 25 anni. I lobi frontali sono la sede di circuiti neuronali legati alle funzioni esecutive, quali la pianificazione, il controllo degli impulsi e la memoria di lavoro. Poiché tali funzioni sono particolarmente collegate e influenzate dal Sistema della Reward, il quale è un circuito fronto-sottocorticale legato alla ricompensa e ai meccanismi di rinforzo di un’esperienza, risultano particolarmente suscettibili ad errori di valutazione e all’attuazione di comportamenti inadeguati, soprattutto se guidati dalla ricerca di dopamina, proprio le fasce d’età corrispondenti ad un non ancora maturo sistema cerebrale. Si parla quindi di adolescenti e bambini.
Di recente stanno aumentando gli studi sull’effetto dell’uso di smartphone e tablet sullo sviluppo delle abilità grosso motorie quali la coordinazione e la propiocezione, così come sulla postura e sulla qualità del sonno. In svariati articoli scientifici si è potuto notare che un maggiore utilizzo degli smartphone nei primi cinque anni di età è correlato ad uno sbilanciamento nello sviluppo delle abilità grosso motorie, così come in altri studi si è evinto che l’errata postura che si assume nell’utilizzo dei dispositivi tende – soprattutto nei soggetti ancora in fase di sviluppo ma anche gli adulti non ne sono esenti – a condurre a disturbi muscoloscheletrici quali cifosi toraco lombare e lordosi lombare, modificando la postura di un soggetto già solo dopo 30 minuti di utilizzo. L’uso eccessivo degli smartphone ha quindi degli effetti anche sulla postura e sulla deambulazione, proprio a causa dello sbilanciamento muscolare che potrebbe derivarne causando potenzialmente dolori alla colonna vertebrale e disturbi muscolari sul lungo termine. Altri studi spiegano come l’esposizione ai dispositivi, soprattutto in tenera età, sia causa di un peggioramento della qualità e della quantità del sonno, così come di una minore tendenza ad essere fisicamente attivi rendendo quindi opportuno, per la promozione della salute del bambino e del futuro adulto, una riduzione dell’utilizzo di tali dispositivi, in particolare nelle ore notturne.
Aspetti psicologici
L’utilizzo eccessivo di dispositivi elettronici, soprattutto a partire da un’età inferiore ai 24 mesi, ha anche un possibile impatto sul linguaggio, che si traduce in un ridotto vocabolario espressivo, una minore abilità linguistica così come un rallentamento nell’apprendimento del linguaggio parlato. Uno studio ha mostrato che un periodo di astensione di sei mesi fosse già in grado di migliorare questo aspetto in bambini con capacità deficitarie nell’ambito del linguaggio. Inoltre, l’utilizzo massivo dei dispositivi è in grado di influenzare negativamente anche la sfera emozionale, aumentando le probabilità di incorrere in disturbi d’ansia e depressivi, oltre che sintomi somatici, ritiro sociale e problemi di attenzione. Altre problematiche considerate collegate all’uso improprio dei dispositivi sono oltre alle difficoltà nella regolazione emotiva, anche l’impulsività, una compromissione delle funzioni cognitive, bassa autostima e timidezza eccessiva.
Inoltre, poiché il sistema nervoso dei bambini e degli adolescenti è ancora in fase di maturazione, l’esposizione a dinamiche virtuali che fanno leva sul Sistema del Reward quali, ad esempio, i like e l’accesso a materiale divertente/interessante di breve durata ma continuo, possono indurre a lungo andare ad una dipendenza dagli smartphone, andando ad accrescere di conseguenza le possibilità di incorrere in problematiche non solamente di tipo emotivo, ma anche di tipo cognitivo, psichiatrico e medico.
Aspetti sociali
Conseguentemente ad una disregolazione emotiva, all’impulsività e a una compromissione cognitiva possiamo autonomamente intuire quali possano essere gli outcome a livello sociale. Le possibilità possono oscillare tra il ritiro sociale completo, con il fenomeno sempre più studiato degli Hikikomori, a condotte comportamentali inadeguate e che potrebbero essere deleterie non solamente per il soggetto, ma anche per i pari e le persone che gli sono attorno. Sono svariati i casi di cronaca relativi all’attuazione di comportamenti disfunzionali dettati dalla ricerca di visibilità, di accettazione e dell’attuazione di atteggiamenti impulsivi che hanno portato soggetti molto giovani a vivere situazioni devastanti dal punto di vista personale e sociale. Tra i più recenti si annovera il caso della ragazza di 14anni che ha partecipato ad una challenge sessuale, dove la regola è quella di avere rapporti sessuali non protetti tra sconosciuti e perde chi rimane incinta.
I casi di bullismo e cyberbullismo che conducono a gesti estremi di chi ne è vittima; la normalizzazione di espressioni e concetti legati alla violenza sessuale e di genere, che portano poi all’attuazione di certi comportamenti, o l’incitamento a compiere atti contro persone, animali e oggetti pur di ottenere visualizzazioni, sono solo alcune delle altre situazioni che sempre più si verificano.
Tra gli elementi alla base di questi comportamenti, dettati da una eccessiva e precoce esposizione ai dispositivi elettronici, si possono trovare sicuramente un calo dell’empatia e una difficoltà nel riconoscimento ed espressione delle emozioni. Questi sono elementi primariamente coinvolti nella comunicazione sia verbale che non verbale, rendendo quindi difficoltoso, impoverito e coartato l’approccio all’ambiente di questi soggetti.
Aspetti legali
Tra questi aspetti possiamo citare l’accesso a certe piattaforme e siti vietate ai minori, argomento altrettanto caldo che sta portando a proposte per la regolamentazione sulla base dell’età. Così come l’iscrizione ai social che – senza alcun tipo di controllo parentale, né educazione adeguata all’uso di internet – possono portare ad entrare in contatto con realtà potenzialmente pericolose o ad attuare comportamenti che possono anche sfociare nel penale. Basti pensare ai gruppi whatsapp o telegram in cui adulti ed adolescenti condividono foto e dati sensibili di altre donne allo scopo di fare revenge porn e ai casi di adescamento di minore. Così come, con tale divieto, si andrebbe automaticamente a dover regolamentare e tutelare anche l’identità digitale dei minori soggetti al fenomeno dello “Sharenting”, ovvero la condivisione online e costante di immagini e video dei propri figli da parte dei genitori. Termine coniato a partire dalle parole inglesi “to share” che significa condividere e “parenting” che significa genitorialità. Un fenomeno sempre più diffuso, soprattutto nell’era degli influencer, che vìola la privacy del minore e lo espone a condizioni che potrebbero diventare eccessivamente negative per il benessere del bambino. Un argomento che, in molti paesi, ha messo in primo piano anche lo sfruttamento minorile che deriva dalla monetizzazione di video, reel, storie e foto, portando baby influencer a denunciare i propri genitori per averli costretti ad una vita digitale che non avevano scelto, sottoponendoli a stress e situazioni difficilmente tollerabili sul lungo termine.
Questa analisi, apparentemente catastrofica, vuole puntare l’attenzione su ciò che dicono gli studi e quali siano gli aspetti negativi che andrebbero disciplinati in un’epoca in cui i cambiamenti digitali non sono andati di pari passo con quelli legislativi. L’obiettivo non è demonizzare, ma informare, anche perché l’accesso ai dispositivi dovrebbe essere preceduto da una corretta educazione digitale che, spesso, manca agli stessi genitori che si ritrovano a non comprendere le dinamiche della rete ed a non saperla spiegare ai figli che la apprendono per errori e tentativi.
La proposta avanzata da Daniele Novara e da Alberto Pellai si aggiunge ad una lunga serie di proposte del tutto simili in svariati paesi Europei ed Extraeuropei e sono anche tanti i paesi in cui questo genere di misure sono già state attivate. Ma c’è da dire che, altrove, vi sono basi culturali differenti con anche alle spalle un sistema che ha saputo integrare e gestire un po’ meglio dell’Italia l’introduzione ai dispositivi e all’uso di internet. Basti pensare a come un livello di scolarizzazione più basso (26,8% con titolo di studio terziario in Italia) rispetto alla media Ue27 (41,6%) possa ad esempio incidere sull’adulto e – di conseguenza – sulla prole di questi adulti in merito alle competenze tecnologiche e digitali. La proposta, di conseguenza, dovrebbe essere corollata di un buon piano di risoluzione della problematica che andrebbe necessariamente a toccare aspetti quali: istruzione, dipendenza da dopamina, parent training, omofobia, violenza di genere, bullismo (ma anche mobbing visto che in età adulta si traduce in ciò), identità digitale, cyberpsicologia, eccetera.
Inoltre, per concludere questa serie di osservazioni è necessario toccare i costrutti giuridici della Capacità di Intendere e di Volere del Codice Penale e la Capacità di Agire del Codice Civile. Sappiamo che con intendere – visto come atto intenzionale – si indica un modo di pensare ordinato e caratterizzato da capacità che consentono alla persona di essere in grado di rendersi conto del valore sociale dell’atto che compie o ha intenzione di compiere, ipotizzandone le conseguenze dirette ed indirette, stabilirne gli eventuali effetti e quali mezzi usare per produrli.
Ai 14 anni viene attribuita l’età del consenso, quindi una capacità del minore di poter effettuare autonomamente delle scelte a livello interpersonale e sessuale. In ambito penale per giudicare un minore come autore di reato deve esserne effettuata una valutazione psicologica che attesti la sua capacità di intendere e di volere, secondo l’art. 85 del Codice Penale. Nell’ambito dell’idoneità del minore a rendere testimonianza si valuta l’attendibilità del soggetto, un concetto collegato a quello di maturità neuronale. Da questi esempi giuridici si può chiaramente intuire che vi sia da prendere in considerazione una certa variabilità soggettiva dei costrutti legati al concetto di maturità, anche in questo contesto. Un minore sarà sempre diverso da un altro coetaneo e circa l’accesso ai dispositivi e ai social, andrebbe valutato ogni singolo caso a sé stante, posto che alle spalle di ogni minore ci sia un adulto caregiver in grado di guidarlo adeguatamente e valutarne la consapevolezza o il grado di incoscienza in modo oggettivo, senza sottostimare o sopravvalutare le competenze del proprio figlio. Un divieto completo, quando la macchina del digitale è stata oramai avviata, potrebbe essere difficile da attuare in toto, ma potrebbe essere un luogo fertile per fare osservazioni meno categoriche e più direzionate ad una integrazione di vari ambiti ed aspetti relativi al mondo dei minori. Andrebbero limitati e sanzionati i comportamenti dei genitori che pubblicano foto e video in cui è riconoscibile chiaramente il minore, andrebbe eseguito un lavoro di “disintossicazione” dai social sugli stessi adulti sottolineando l’importanza dell’interazione reale con i figli, limitando anche il proprio uso dei dispositivi soprattutto nei primi anni di età (vi è una correlazione tra uso da parte dei genitori e difficoltà nello sviluppo dell’infante). Andrebbe posto un divieto più stringente dei dispositivi all’interno delle aule scolastiche, andrebbero coinvolte le compagnie telefoniche per istituire dei piani specifici sulla base dell’età dell’usufruitore del dispositivo. Allo stesso modo, sarebbe urgente che le piattaforme online aumentassero i controlli e migliorassero le procedure di iscrizione per limitare l’accesso dei minorenni tramite escamotage. Un ulteriore aspetto su cui si potrebbe lavorare sarebbe la personalizzazione delle esperienze sui social in base all’età, così come sarebbe fondamentale, soprattutto all’interno degli studi pediatrici o attraverso corsi per i neo-genitori, quello di promuovere una metodica di parenting che faccia comprendere appieno l’importanza di rispettare le tappe dello sviluppo neuropsicofisiologico del proprio bambino.
Alla luce di quanto detto, non si tratterebbe sicuramente di una rivoluzione semplice, ma per attuare un divieto di tale portata è sicuramente necessario tenere in conto tutti questi aspetti e puntare su una evoluzione legislativa, oltre che sociale, per riuscire a gestire adeguatamente gli effetti di una digitalizzazione troppo precoce.
Link petizione
Link pubmed
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804281-6.00019-7
https://www.nature.com/articles/nn1099_859
10.1016/j.jadohealth.2009.05.016
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38587808/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30930581/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35749821/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37761740/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34444119/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32120178/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37854747/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34002549/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34140904/
Altri Link
https://tg24.sky.it/mondo/2024/05/03/smartphone-minori-regole-italia#00
https://tg24.sky.it/mondo/2024/05/03/smartphone-minori-regole-italia
Cosa succede ai figli quando la separazione dei genitori avviene in maniera altamente conflittuale? Che si intende per alienazione, e come questo concetto deve essere trattato in ambito giuridico? Cosa e come osservare e ascoltare il minore nel lavoro consulenziale?
Il pacchetto formativo che abbiamo messo a punto per te, consente l’acquisizione di competenze e strumenti fondamentali per svolgere in maniera professionale il lavoro di osservazione e ascolto del minore in ambito psico-forense.

Pacchetto di 3 Corsi On Demand
Il lavoro con i minori in ambito psico-forense
Durata del Corso: 18 ore
Dal nostro Blog

2,3 miliardi di bambini e adolescenti: il futuro dell’umanità chiede ascolto

Transgender Day of Remembrance: tra consapevolezza collettiva e tutela dei diritti

Vittime della strada: prevenzione e trauma. Il ruolo centrale della psicologia
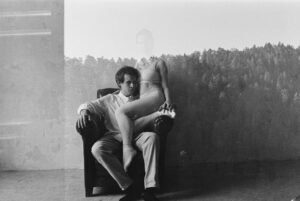
Esplorazione clinica della folie à deux

La violenza non è solo fisica ma anche e soprattutto psicologica





Webinar utilissimo, molto formativo, svolto da importanti personalità. Sono onorato di aver partecipato.