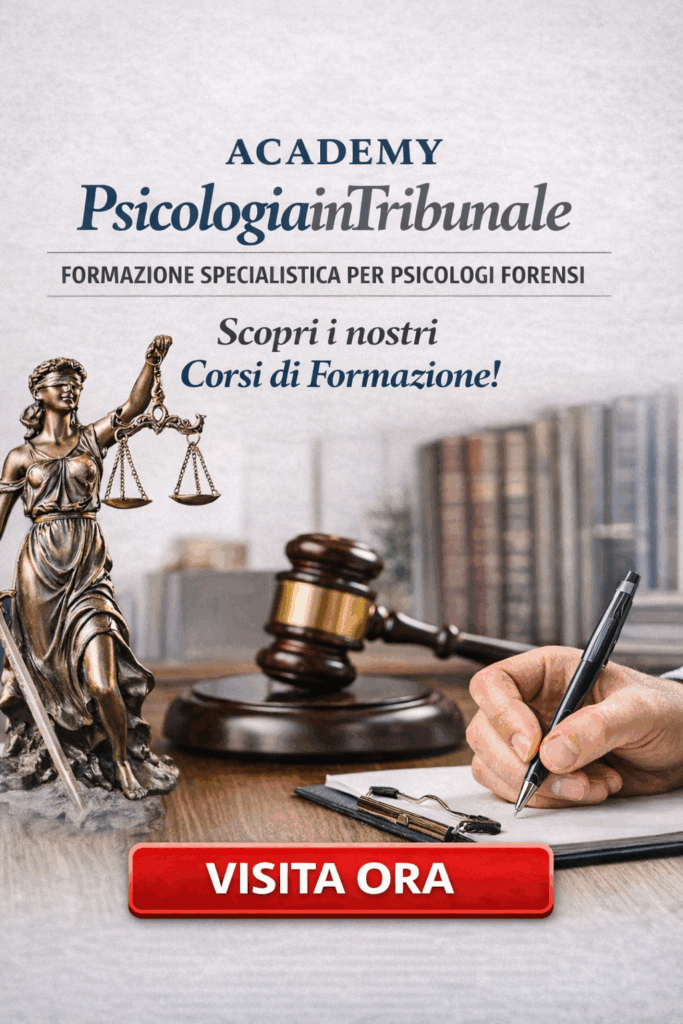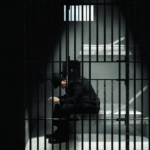Per un’etica in diritto di famiglia. Il ruolo dello psicologo dalla consulenza alla formazione

Per un’etica in diritto di famiglia. Il ruolo dello psicologo dalla consulenza alla formazione
Sabrina Tosi, CTU e Perito del Tribunale di Macerata, Giudice Onorario presso il Tribunale per i minorenni di Ancona
Sivia Busini, CTU e del Tribunale di Macerata
In ambito giurisprudenziale sta maturando la consapevolezza del bisogno di un’etica e una deontologia differente per le controversie familiari. Questo richiede alla psicologia una condivisione di parte del proprio sapere con il mondo giuridico, condivisione che può sfociare auspicabilmente in una maggiore coerenza tra il fare psicologico e quello giuridico. Tale rivoluzione riveste sia gli ambiti strettamente applicativi dello psicologo giuridico (le consulenze tecniche d’ufficio e di parte) sia i contesti di formazione degli operatori del diritto (corsi per avvocati e magistrati).
In tutto il territorio nazionale e in alcuni contesti con maggiore sensibilità, sta maturando, in campo giuridico, l’esigenza di definire un’etica e una deontologia professionale specifica per gli avvocati che si occupano di diritto di famiglia – i cosiddetti matrimonialisti. Il titolo della presente trattazione – che vuole configurarsi come uno spazio di riflessione – è stato infatti preso in prestito da un evento organizzato dall’Ordine degli Avvocati della Provincia di Macerata il 15 marzo 2015.
Sebbene tale evidenza possa sembrare scontata per chi – come lo psicologo e a maggior ragione lo psicoterapeuta – è stato formato per relazionarsi con l’individuo e la famiglia rispettando un codice deontologico ma soprattutto con una dimensione etica specifica, lo stesso percorso formativo non ha riguardato l’avvocato matrimonialista.
L’esigenza di definire un sistema di regole che disciplini il comportamento dell’avvocato per le questioni familiari nasce molto probabilmente da una serie di frustrazioni che riguardano tanto l’avvocato quanto i diversi soggetti coinvolti nei procedimenti giudiziari in tale campo.
L’Avvocato. Coinvolto nella disputa coniugale, triangolato dalla coppia all’interno della loro relazione, reso complice nella collusione con il proprio assistito a discapito del minore, frequentemente non gratificato dalla soddisfazione finale dell’assistito, vive spesso inconsapevolmente questa serie di processi che generano uno stato di frustrazione.
Il Giudice. Sia esso individuale o in un collegio con altri magistrati (mal comune mezzo gaudio), nutre un sentimento di frustrazione nel verificare che il decreto emesso da egli stesso o da altri colleghi non ha in realtà posto fine alla disputa di coppia ma ha semplicemente segnato il confine tra un round e quello successivo.
Lo Psicologo Consulente Tecnico d’Ufficio. Egli si presta a impiegare le proprie risorse per muoversi tra le linee guida dello psicologo in campo giuridico* da un lato, e le conoscenze in campo clinico dall’altro. Se le prime dettano una serie di procedure a cui egli deve attenersi per garantire ai periziati una uniformità operativa ma anche un sistema di strumenti dotati di scientificità, le seconde sono ciò che permettono di rendere la CTU un “processo potenzialmente in grado di far uscire la famiglia da uno stallo evolutivo iatrogeno** per i membri della coppia ma ancora più gravemente sulla prole”.
Il Consulente Tecnico di Parte. Spesso investito di un mandato confuso si trova – ad operazioni peritali avviate – a non sentirsi pienamente in quel ruolo in cui tanto l’assistito quanto l’assistente (legale) si aspettano che perori integralmente la loro causa a prescindere dal fatto che il disagio manifestato dal Minore coinvolto nella disputa sia causato quasi sempre anche dal suo assistito. In aggiunta a ciò il CTP con esperienza in campo relazionale è consapevole del fatto che sposare la causa dell’avvocato e del suo assistito (collusione) più che condurre alla risoluzione della controversia produce quel contrappeso che alimenta la forza con cui entrambi partecipano al conflitto. In questo senso il ruolo del CTP se da un lato è quello di garantire al proprio assistito la correttezza nello svolgimento delle operazioni peritali, dall’altro il ruolo realmente risolutivo è quello di fare luce al proprio assistito rispetto alle proprie responsabilità messe in campo nello strutturarsi della vicenda giudiziaria.
Gli Assistiti. Intervistando i legali vengono definiti spesso egoisti, arrabbiati, disperati, irragionevoli. La loro insoddisfazione a conclusione della disputa è la prova che le controversie in campo familiare sono battaglie senza vincenti. Lo psicologo avendo conoscenza dei processi di adattamento alle crisi evolutive (Scabini, 1998) sa che non sono sempre individui patologici ma più spesso si tratta di sistemi in fase di riorganizzazione o in stallo evolutivo e in quanto tali possono perdere di vista il patrimonio che la coppia deve tutelare: il figlio. Questo meccanismo è estremamente evidente quando gli stessi CTU, formati per riconoscere funzionamenti familiari adeguati vs disfunzionali, vengono coinvolti personalmente in dinamiche di separazione coniugale manifestando quei comportamenti “sintomatici” riconducibili prevalentemente a meccanismi di adattamento ad una crisi evolutiva.
Se questa serie estesa di frustrazioni rappresenta la base su cui si fonda l’esigenza di parlare di un’etica e di una deontologia in Diritto di famiglia, questo comporta un dovere etico e deontologico per lo psicologo di fornire al campo del Diritto e della Giurisprudenza quel sapere che la psicologia e la psicoterapia (in campo evolutivo e familiare) hanno maturato nel corso della propria crescita scientifica. Sarà compito poi dei diversi organi della giurisprudenza (legislatura, magistratura, avvocatura ecc.) quello di costruire su quel sapere il proprio saper fare.
È su questo mutamento che sempre più frequentemente lo psicologo verrà interpellato a fornire il proprio sapere sia come consulente di parte e di ufficio, sia come relatore ad eventi formativi su argomenti riguardanti la famiglia.
È necessario allora interrogarsi su quali aspetti del sapere psicologico siano utili al campo giuridico considerando che la psicologia giuridica è il territorio di confine attraverso cui questi argomenti dovranno passare. Perché in questo spartiacque la psicologia ha il compito di lasciare una parte del proprio sapere e saper fare (parte delle sue specificità) per acquisire parte del sapere e saper fare che caratterizza l’ambito giuridico. Il sistema giuridico, in un ottica sistemica, è infatti il sottosistema a cui è demandata la funzione di omeostato sociale, di riportare cioè i comportamenti devianti all’interno di un range predefinito con lo scopo di far funzionare l’intero sistema sociale. E’ su questa definizione che si fonda la natura pragmatica del diritto e della giurisprudenza ed è su questa peculiarità che lo psicologo giuridico deve fondare i propri interventi.
Laddove la deontologia in diritto di famiglia porta il sapere teorico della psicologia nel campo applicativo del diritto, l’etica permette lo spostamento del diritto nel campo teorico della psicologia.
Uno degli assunti fondamentali su cui si basa lo psicoterapeuta sistemico familiare – quello del fisico e filosofo austriaco Heinz Von Foester – afferma che “dato un osservatore A o sistema osservante – come un terapeuta, un giudice, un avvocato – e un osservato B o sistema osservato – un individuo, una coppia, una famiglia – nella relazione tra A e B si modificano tanto l’elemento A quanto l’elemento B (Von Foester). Questo pone il terapeuta all’interno di una cornice in cui si dissolve il concetto di neutralità e si espande quello di responsabilità (Bianciardi, 2014).
Il mandato pragmatico della giurisprudenza richiede una contestualizzazione del costrutto di base di Von Foester alla realtà operativa dei diversi professionisti. La caduta del concetto di neutralità nelle vicende familiari dovrebbe indurre il giudice, l’avvocato o il Ctu a cambiare le proprie domande. Quesiti come “chi ha ragione, chi deve essere punito, chi non assolve realmente ai compiti genitoriali, chi ha maggiori competenze genitoriali?” possono essere sostituite con “quale proposta (nel decreto, nel ricorso, nella relazione di CTU) è in grado di far uscire la famiglia dal proprio stallo? Quale disposizione, o ridefinizione o informazione può creare una perturbazione tale da indurre la famiglia immersa nella palude del conflitto a costruire una nuova organizzazione. Quale rete è in grado di fornire alla famiglia un sostegno per costruire questa nuova organizzazione?
Cambiando la tipologia di domanda ci troviamo subito nel campo della responsabilità dell’operatore che con il proprio intervento – con ill proprio entrare in relazione con – è in grado di proporre perturbazioni quanto di dare stabilità ulteriore allo stallo o, in estremo, a provocare l’attivazione di processi schismogenetici*** (Bateson, 1977).
L’avvocato che istruisce una pratica, che scrive un ricorso, che semplicemente in silenzio, ascoltando il suo assistito, alza il sopracciglio o sgrana gli occhi deve essere consapevole del ruolo che può avere nella famiglia che porta in Tribunale, anche se il suo mandato è stato conferito da un solo membro di quella famiglia.
Ovviamente la spiegazione relativa al mandato professionale conferito dal suo cliente può essere sufficiente a giustificare l’evoluzione del percorso giudiziario; in realtà la variabile psicologica fa la differenza nel processo che converte la domanda che il cliente rivolge all’avvocato di fiducia nell’azione giudiziaria che quest’ultimo andrà ad intraprendere. I clienti si rivolgono infatti agli avvocati solitamente in una “fase di destabilizzazione biopsicosocioecologica del contesto“. Biologico: l’organismo che ricorre alla legge è un individuo stressato e lo stress coinvolge anche il corpo in senso stretto nel sistema neurovegetativo e nel sistema limbico con ripercussioni quindi sugli stati emotivi, sulle funzioni biologiche di base (mangiare, dormire, ecc.). Psicologico: c’è un processo di elaborazione in corso che induce la persona a confrontarsi con i propri successi e insuccessi, con il proprio senso di adeguatezza o con le scelte sbagliate; in alternativa c’è un grosso lavoro psicologico per non affrontare tutto questo spostando all’esterno tale processo, definendo un colpevole che spesso, appunto, viene individuato nell’ex coniuge o nella sua famiglia d’origine. Da qui il problema diventa sociale, sulle relazioni esterne e ecologico cioè sul contesto di vita che viene sottoposto a una serie di cambiamenti.
Tali processi sono per lo più transitori anche se a volte si irrigidiscono e si cronicizzano per tante motivazioni, tra cui, provvedimenti sbagliati.
L’avvocato spesso preparato sulle procedure manca di una formazione specifica per riuscire a riconoscere tali processi e comprendere come muoversi con un atteggiamento adeguato.
Il Giudice. Il ruolo del giudice è potente rispetto alle dinamiche relazionali delle persone coinvolte nella vicenda giudiziaria. Il Giudice, nel suo forte mandato istituzionale è potente per l’avvocato, per il CTU, per i consulenti di parte. Inevitabilmente tale percezione di potenza si trasferisce sulle persone assistite con ovvie eccezioni per le personalità sociopatiche.
Per il CTU che lavora in una prospettiva perturbativa la potenza del giudice può essere utilizzata per agire con efficacia sullo stallo della coppia coinvolta nel procedimento. In aggiunta a questo un’altro elemento rende forte l’azione del CTU – è la componente affettiva che connota l’intero procedimento per le parti in causa.
Dopo aver evidenziato le responsabilità degli attori del processo giudiziario – le parti, gli avvocati, i giudici, è necessario chiudere il cerchio sul ruolo del CTU che non può esimersi dal garantire una formazione fondamentale oltre che in psicologia giuridica anche nella conoscenza dei processi relazionali che caratterizzano i sistemi familiari.
La figura del CTU si va definendo progressivamente ma ancora troppo lentamente. L’Ordine degli Psicologi Nazionale (CNOP) nel 2003 ha demandato ai singoli ordini regionali di disciplinare l’accesso dei CTU agli albi tenuti presso i Tribunali, lasciando alle singole regioni di definire i requisiti minimi per accedere a tali albi con evidenti situazioni di eterogeneità. E’ del 2018 il documento che punta a superare tale criticità e che prevede nuovi criteri per la formazione e l’aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali (Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell’art. 14 del Protocollo d’intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018).
Ma anche in questo caso non si può demandare la responsabilità – in diritto di famiglia – alla sola deontologia professionale, alle norme e ai requisiti minimi.
Ricondurre la responsabilità in diritto di famiglia alla sola deontologia è come mangiare la minestra con la forchetta. L’etica è la sola strada per garantire la tutela dei soggetti deboli coinvolti nelle vicende giudiziarie che riguardano la famiglia, soggetti che in tal caso, non si identificano nei soli minori ma anche negli adulti.
Per concludere, parlare di un’etica in diritto di famiglia significa modificare la cornice all’interno della quale operano i professionisti; significa aprire ulteriormente un dibattito tra discipline, tra campi del sapere diversi; significa allenarsi allo scambio tra questi saperi nella consapevolezza del ruolo sociale che ciascuno dei professionisti svolge. Significa inoltre aprire la strada ad un elemento, il bisogno di formazione degli operatori in tale direzione; se fino ad oggi infatti nel campo del diritto di famiglia si è compreso il bisogno di dare informazione, nella prospettiva sopra evidenziata assume valore il ruolo del fare formazione a tali operatori.
NOTE
* ww.aipgitalia.org/index.php/linea-guida/linee-guida-per-lo-psicologo-giuridico-aipg
* Carta di noto IV
** Iatrogeno è quel fattore legato causalmente all’insorgenza di uno stato patologico, quel tentativo di soluzione di un problema che genera un disagio.
*** La schismogenesi è un processo di differenziazione nelle norme del comportamento individuale risultante da interazione cumulativa tra individui. Essa viene descritta dallo scienziato Gregory Bateson osservando le popolazioni indigene della Nuova Guinea (Bateson, 1936). Essa è un processo relazionale in cui le interazioni dei membri che partecipano agli scambi comunicativi si accumulano portando ad una progressiva divisione delle parti fino alla rottura.
BIBLIOGRAFIA
A.I.P.G. (2019). Linee guida per lo psicologo giuridico in ambito civile e penale.
Bateson G. (1988), Naven, Einaudi.
Bateson G., (1977), Verso un’ecologia della mente, Adelphi.
Bianciardi M., a cura di, (2012), Psicoterapia come etica. Antigone.
Gulotta G., Camerini G.B. (2014), Linee Guida Nazionali L’ascolto del minore testimone.
Giuffrè Scabini E., (1998), L’organizzazione famiglia tra crisi e sviluppo, Franco Angeli