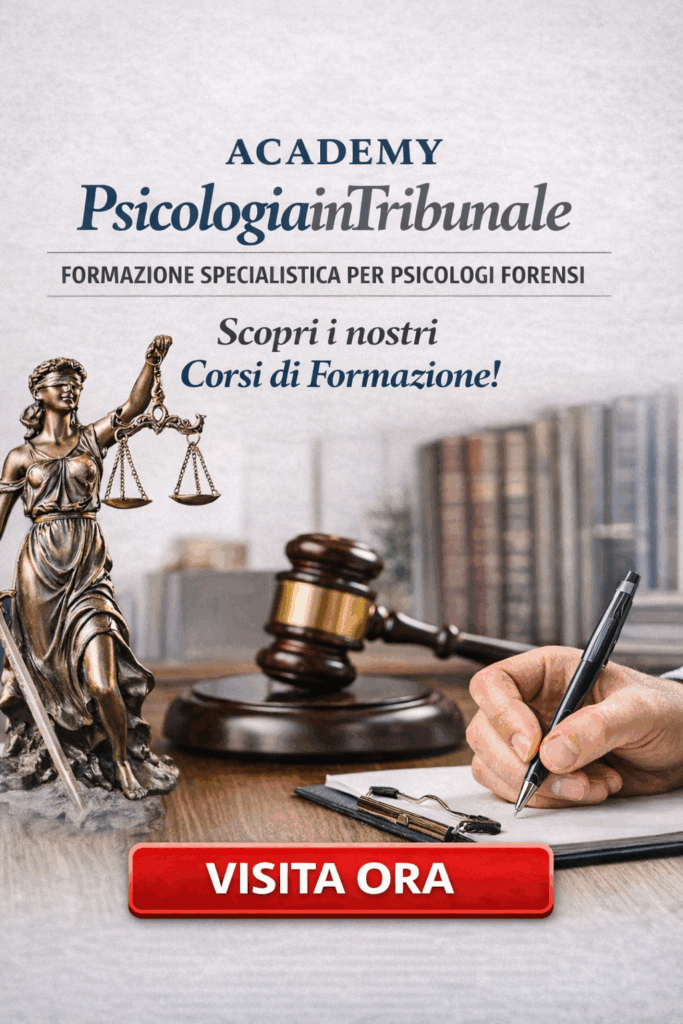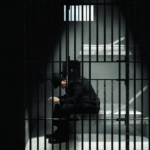La CTU, complessità oltre i luoghi comuni
di Francesca Siboni
Psicologa Clinica e Forense, Psicoterapeuta per adulti e bambini secondo il Modello Tavistock, Professionista della rete di Psicologia in Tribunale.
Quando si attiva una CTU uno dei primi elementi critici è quello di riuscire ad elaborare un inquadramento, che è anche una ricostruzione della storia familiare del contesto relazionale, entro il quale collocare i quesiti posti dal giudice in primis, ma anche le istanze presentate dagli avvocati e le letture, che si sono attivate nei CCTT della situazione stessa. Esiste quindi una molteplicità di prospettive e di elementi presenti nella storia familiare, che vanno progressivamente ricondotte ad un quadro psicologicamente significativo della posizione dei singoli componenti la famiglia, dei vissuti e degli atteggiamenti, che ciascun elemento della famiglia ha espresso rispetto alla situazione conflittuale. Purtroppo si avverte la mancanza, nei fatti, di un criterio per l’affidamento e la gestione dell’attività di consulenza peritale che evidenzi le specifiche competenze del perito in relazione alla situazione sulla quale deve intervenire.
I più frequenti luoghi comuni
Spesso si strutturano alcune convinzioni o luoghi comuni in chi svolge l’attività psicoforense. Espressioni che sicuramente colgono una dimensione fenomenologica dei vissuti conflittuali, ma che rischiano a volte di trascurare i diversi assetti psicologici e relazionali, che possono caratterizzare ciascun genitore.
“Gli avvocati dovrebbero fare un passo indietro”; “La coppia ha un elevato conflitto”; “Il quesito non è ben posto”; “Non c’è una parte che vinca o che perda”; “Quando c’è un minore che ha problemi di relazione con un genitore, è più facile dare ragione all’altro”; “Il bambino ha due genitori”; “I CTP dovrebbero fare un lavoro in collaborazione”; “I veri problemi vengono dopo la CTU”; “La CTU non è una terapia”; “La CTU non deve dire chi ha ragione né svolgere indagini”, e così via.
Capacità di contenimento del CTU/CTP
Durante il procedimento giudiziale l’assunzione di decisioni fortemente prescrittive introduce nella dinamica del gruppo dei soggetti coinvolti un forte elemento persecutorio. Per poter affrontare situazioni conflittuali come consulenti del giudice o perché chiamati dalle parti in causa per tentare di dirimere il conflitto, è necessario che il consulente abbia un’esperienza consolidata sia in termini di psicopatologia sia in termini di capacità di contenere dentro di sé quelle che sono le tensioni e le proiezioni della famiglia. Per proiezione si intende attribuire agli altri uno stato d’animo o una caratteristica che serve a chi proietta per difendersi dal possedere tale caratteristica. Ancora di più il clima persecutorio della conflittualità dispone i genitori ad attribuire all’esterno, come difesa dalla colpa, ciò che riguarda una loro incapacità o inadeguatezza.
Rischio di collusione
Un aspetto che coinvolge avvocati e consulenti riguarda il rischio di colludere, ovvero di sposare il punto di vista parziale di una parte, appunto colludere con aspetti parziali in una situazione complessa e ricca di implicazioni emotive. Il rischio di collusione, ovvero di sposare, di far proprio, di identificarsi con la posizione di uno dei due genitori, sulla base di una storia pregressa mai completamente conosciuta (da parte degli avvocati e consulenti), può generare una distorsione nella lettura che viene data della situazione di conflitto e delle risorse presenti nei genitori e nei minori, distorsione che rischia di appiattire ai vissuti soggettivi una dimensione relazionale, che per sua natura è complessa e soprattutto vede negli atteggiamenti dell’insieme la partecipazione di tutti, del sistema familiare dal quale nessuno è escluso.
In ogni richiesta ci sono delle aspettative esplicite e implicite. Esplicita, per esempio, è valutare la qualità della relazione esistente tra genitore e figlio; implicita, può essere quella, nei casi di grave conflittualità, di valutare l’attendibilità delle varie posizioni. Questo può portare l’attenzione del CTU non sufficientemente strutturata da un’esperienza formativa e professionale adeguata nell’area forense o giuridica, a focalizzarsi in un processo di lettura altamente soggettivo ed autoreferenziale, perché la valutazione dell’attendibilità non può essere fatta in termini oggettivi. Una valutazione sulla attendibilità, ad esempio, non solo è estranea alla capacità valutativa del perito in quanto presuppone un lavoro di comparazione tra singoli elementi dei comportamenti con le affermazioni e con la storia pregressa, ma è anche difficilmente sostenibile da tecniche valutative obiettive e scientificamente condivise.
Complessità relazionali
L’inizio di un lavoro peritale si colloca su una serie di relazioni che già coinvolgono gli attori in campo: il ricorrente rispetto al resistente; gli avvocati che impostano gli elementi di riflessione e le istanze al giudice, ovviamente nel miglior interesse del cliente; ciascun genitore della coppia nella gestione della relazione col figlio; ciascuno dei due genitori nel gestire in accordo o disaccordo con l’altro i vari processi educativi; e i rapporti con tutte le altre figure presenti nell’accudimento del figlio, nonni, zii, medici, baby sitter, allenatori sportivi, relazioni, che si sono sviluppate e che non solo tessono la situazione, ma possono anche frammentarla.
Una risposta a questa complessità relazionale è stata, ad esempio, la proposta dei Piani Genitoriali con lo scopo di ripristinare o costruire, ex novo, una modalità di accudimento genitoriale del figlio.
Diacronie narrative
A questo si aggiunge un altro livello di realtà relazionale, quello dato dai legami emotivi e affettivi, che in ogni famiglia modulano le vicinanze o le lontananze di ciascuno e quelle reciproche. Tutto questo riceve, in modo un po’ shakespeariano, una propria narrazione a seconda dell’interlocutore, in primis l’avvocato, il giudice ed anche i consulenti nominati dalle parti. Da qui la diacronia, perché tutto questo avviene in una situazione diacronica, in tempi e in modi diversi, sia per quanto riguarda l’acquisizione degli elementi sia il loro prodursi. Ad esempio, è sovente molto difficile e delicato individuare quale sia la reale causa della conflittualità coniugale o dell’esplosione di legami alternativi (amante, amici, ecc). Un genitore può investire in una relazione extra coniugale o può essere indotto dall’altro a farlo.
In realtà, le motivazioni interne, che hanno portato alla situazione, che arriva davanti al giudice sono molteplici e aperte a varie letture e interpretazioni necessariamente a seconda del livello di profondità alla quale ci si pone. Motivazioni sociali, emotive, economiche, relazionali, a partire da quelle personali, caratteriali, familiari o con famiglia estesa, alle motivazioni economiche, lavorative, sociali e religiose. Ciascuno dei professionisti coinvolti introduce una lettura dettata da elementi oggettivi, che vengono loro riferiti e da istanze etiche o di valore sociale, che sono evocate.
Nel momento in cui si attivano tutte queste figure, si cerca di raggiungere una visione di sintesi il più possibile corretta e coerente da parte di tutti. In questo senso, si ritiene da molti che l’attività legata alla giustizia sia un processo di ricostruzione corale e collettivo, in quanto coinvolge varie figure. Processo di sintesi corale, che trova ostacoli, difficoltà o paralisi e limiti proprio nella conflittualità, palese oppure scontata, a volte, la conflittualità, che percorre le relazioni di coppia genitoriale. Difficilmente la conflittualità è espressa con modalità simmetriche o caratterizzanti entrambi i genitori, ciascuno è legato alla propria natura, personalità e condizionato anche dalla modalità con la quale progressivamente viene definita la situazione. Questo può creare conflitti arbitrari/ingiustificati tra avvocati e consulenti. Modalità diverse nelle ricostruzioni personali spesso sono alla base di una difficoltà, che a volte si tramuta in un oggetto di conflitto da parte degli avvocati, proprio per questa caratteristica diacronica. È molto delicato il ruolo in questo senso che svolge il professionista CTU nel riconfigurare lo scenario.
Ogni volta che si elabora una narrazione di una realtà complessa, di ogni realtà complessa, se ne opera una trasformazione. C’è uno scenario A che riguarda la dimensione individuale e soggettiva di tutte le persone coinvolte, uno scenario B che riguarda le narrazioni e le sintesi, che progressivamente vengono elaborate da ciascun professionista sulla base della propria competenza ed esperienza. Queste narrazioni possibili giustificate dai vari punti di vista e prospettive di lettura sono un’operazione molto delicata, ancor più delicata se inseriamo in questi rapporti la dimensione del conflitto. Conflitto che, conseguentemente, verrà letto e vissuto da varie angolature.
Cambiamento vs adattamento
Da un punto di vista psicologico, ben sappiamo come, da una parte, il desiderio di ricevere aiuto dall’altro, il bisogno di richiedere conferme per i propri dubbi e angosce, spinga le persone a dipendere da quanto viene loro proposto come lettura autorevole. Questa considerazione fa sì che difficilmente un intervento non produca effetti sulle persone coinvolte. Però questo non deve tuttavia portare a fraintendere quello che è un adattamento alla situazione di fatto come si sta svolgendo da una reale elaborazione delle motivazioni del conflitto. Sia i giudici che i periti possono considerare come cambiamento quello che è semplicemente un adattamento.
Ogni relazione (coi periti ad esempio) induce un cambiamento, bisogna valutare di che natura sia e quanto sia profondo, quanto sia reale e quanto duri nel tempo. Per quanto riguarda il conflitto tra genitori e figli o tra figli e genitori, non è detto che sia reciproco. Un elemento della famiglia può essere in conflitto con l’altro e l’altro non esserlo, per esempio tra figlio e padre e viceversa.
La sofferenza espressa dai figli verso i genitori non necessariamente si esprime in un conflitto, ma in uno stato di sofferenza e di ferita o di svalorizzazione del proprio sé. È difficile che un bambino viva la figura genitoriale come incompatibile, potrà essere ambivalente, spaventato, ma non in termini di incompatibilità. Il conflitto può essere tra un’istanza interna tipo amore e odio dalla quale l’Io cerca di difendersi, negando, spostando, sublimando le pulsioni negative nei confronti del genitore. Tra queste difese ci può essere anche quella che riguarda il disinvestimento dell’altro, se questo conflitto non nasce internamente, ma deriva da atteggiamenti dell’altro.
In sintesi
Muoversi all’interno della complessità generata in un nucleo conflittuale familiare in cui possono essere presenti anche comportamenti violenti o reciprocamente ricattatori, da quanto sopra richiamato, richiede un processo di gerarchizzazione dell’importanza dei vari elementi presenti e giustificanti per i singoli soggetti l’atteggiamento da loro esplicitato. La gerarchizzazione permette di individuare i diversi livelli ai quali le posizioni individuali fanno riferimento e quindi articolare la conoscenza della situazione rispetto alla quale bisogna esprimere una valutazione
con una maggiore consapevolezza delle ricadute sui singoli che giudizi, valutazioni tecniche, indicazioni operative hanno sulla vita dei vari componenti il nucleo familiare così tanto travolto dalla conflittualità.
Bibliografia di riferimento
Cigoli V., Clinica del divorzio e della famiglia ricostruita, Bologna, Il Mulino, 2017.
Morin E., La sfida della complessità, Firenze, Le lettere editore, 2017.
Uguzzoni U., Siboni F., “Introduzione”, in La prospettiva del minore nella CTU, Milano Franco Angeli,
2012.
Winnicott D., Sviluppo affettivo e ambiente, Roma, Armando editore, 2018