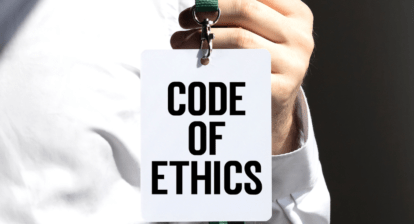Lucrezia Colmayer
Avvocata penalista, esperta nella tutela delle donne vittime di violenza, componente della Commissione Progetto Donna e Procedura penale dell’Ordine degli Avvocati Roma.
È di pochi giorni fa la notizia della prima ordinanza di ammissione di un imputato al percorso di giustizia riparativa.
Ciò che ha fatto più discutere, però, non è tanto l’applicazione di questo nuovo istituto, inserito nel nostro ordinamento dagli artt. 42-67 del decreto legislativo n. 150/2022, (cd “riforma Cartabia”) ma il fatto che lo strumento venga utilizzato in un processo per un femminicidio particolarmente efferato.
In particolare, l’istanza di ammissione al programma di giustizia riparativa è stata avanzata da David Fontana, condannato già in primo grado alla pena di 30 anni per il femminicidio di Carol Maltesi, sua vicina di casa con la quale intratteneva una relazione sentimentale. L’assassino, dopo omicidio, si accaniva sul cadavere facendolo a pezzi per poi disfarsi dei resti della partner gettandoli da un burrone.
Per poter commentare la decisione della Corte di Assise di Busto Arsizio(1), però, è opportuno premettere dei brevi cenni sull’istituto della giustizia riparativa.
Si tratta di una delle maggiori innovazioni inserite nel nostro ordinamento dalla Riforma Cartabia che, anche a seguito delle forti sollecitazioni sul punto in ambito internazionale(2), è intervenuta con alcune interpolazioni nel Codice penale e di rito.
L’art. 42 del d.lgs. 150/2022 definisce come giustizia riparativa: ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore.
Viene considerata, invece, come vittima del reato: la persona fisica che ha subìto direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona.
Occorre fare chiarezza immediatamente sul fatto chela giustizia riparativa, si inserisce nel nostro ordinamento come un percorso parallelo e non alternativo al sistema sanzionatorio e, dunque, non è un modo per il reo di evitare l’espiazione della pena.
Per completezza, tuttavia, non si può tacere che il legislatore ha previsto di poter tenere in considerazione l’eventuale esito positivo del programma mediante il riconoscimento di una particolare attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p.(3)
Alla luce della prima ordinanza ammissiva, ciò che più fa riflettere sono le reazioni che tale strumento ha suscitato, soprattutto nei familiari della giovane vittima che sin da subito hanno manifestato il loro dissenso e la volontà di non aderire al programma.
Ed allora, ci si potrebbe chiedere, perché l’imputato è stato ammesso al percorso in esame?
Sul punto può essere interessante analizzare l’ordinanza della Corte di Assise di Busto Arsizio che, lungi dal voler imporre alle parti civili costituite di partecipare al programma di giustizia riparativa, ricorda come il nostro legislatore abbia previsto la possibilità di predisporre programmi con “vittima aspecifica”.
L’istituto, infatti, è caratterizzato dalla volontarietà e dalla spontanea adesione di tutti i soggetti coinvolti lontano, dunque, da qualsiasi costrizione.
L’ordinanza in questione, infatti, richiama il valore pubblicistico dell’istituto volto a sanare la frattura tra il reo e la società che è ispirato al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena contenuto nel terzo comma dell’art. 27.
La stessa Corte sottolinea come “lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa (n.d.r. nel caso di specie) non comporta alcun pericolo per l’accertamento dei fatti, già giudicati in primo grado”.
Diverso è il caso in cui ci si trovi di fronti a reati procedibili a querela poiché il buon esito del percorso riparativo viene considerato incompatibile con la volontà di punizione.
Dal punto di vista del reo, non si può non pensare alla giustizia riparativa come un’occasione per comprendere la gravità della propria condotta cercando di aggiungere alla pena detentiva un percorso personale che possa dare valore e significato ulteriore alla privazione della libertà personale.
In questo modo l’istituto sembrerebbe mettere al centro l’esigenza della persona che ha commesso l’offesa (l’ordinanza riporta le dichiarazioni dell’imputato rispetto alla possibilità di permettergli “di fare qualsiasi cosa, percorsi, di seguire programmi, qualsiasi cosa sia possibile fare verso i parenti e verso altre associazioni) quando uno degli obiettivi della giustizia riparativa dovrebbe essere quello di tenere in forte considerazione le vittime e le loro esigenze.
Il tema della giustizia riparativa si interseca con il tema della vittimizzazione secondaria poiché, soprattutto nei casi di violenza di genere, si avverte il rischio che nel corso del programma prevalgano le posizioni dominanti che nascondono il meccanismo tipico della violenza che tendenzialmente svantaggia la parte più debole (in questo caso la vittima) già provata dalla violenza subita.
Tuttavia, bisogna ricordare che l’applicazione della giustizia riparativa nel nostro ordinamento è prevista per qualsiasi tipologia di reato e ciò non sembra essere in contrasto neppure col il dettato della Convenzione di Istanbul che, in casi di violenza di genere, vieta il ricorso, qualora obbligatorio, a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie.
In conclusione, l’analisi giuridica e legislativa della giustizia riparativa non risolve tutti i dilemmi e dubbi morali che la questione porta con sé:
- come porre rimedio al dolore?
- che prezzo dare alla sofferenza patita dalla vittima e dai suoi familiari?
Solo il tempo e l’effettiva applicazione saranno in grado di restituire i risultati di questa esperienza, da un lato la capacità di prevenire la commissione di nuovi reati e dall’altro la possibilità di rimettere al centro le esigenze delle vittime troppo spesso relegate ad una funzione marginale nel processo penale.
Note
(1) Sentenza della Corte d’Assise di Busto Arsizio
(2)NAZIONI UNITE 2002: Basic principles of the use of restorative justice programmes in criminal matters; DIRETTIVA 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012; RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO D’EUROPA CM/REC (2018); RACCOMANDAZIONE R (99)19 DEL CONSIGLIO D’EUROPA.
(3) “L’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; o l’avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati”.
Dal nostro Blog